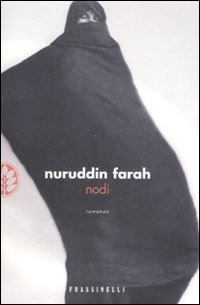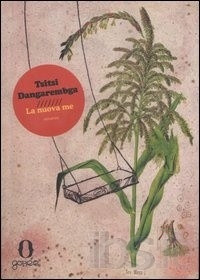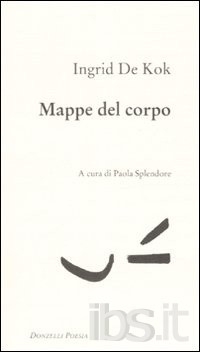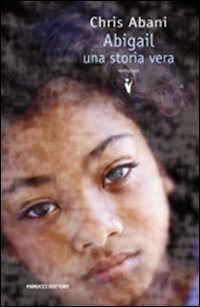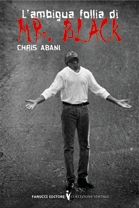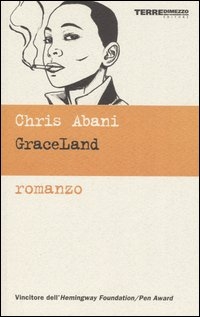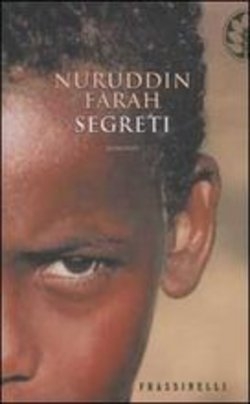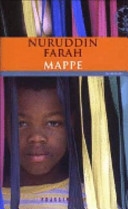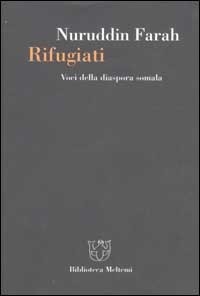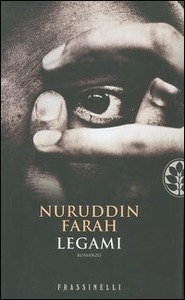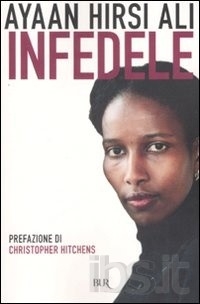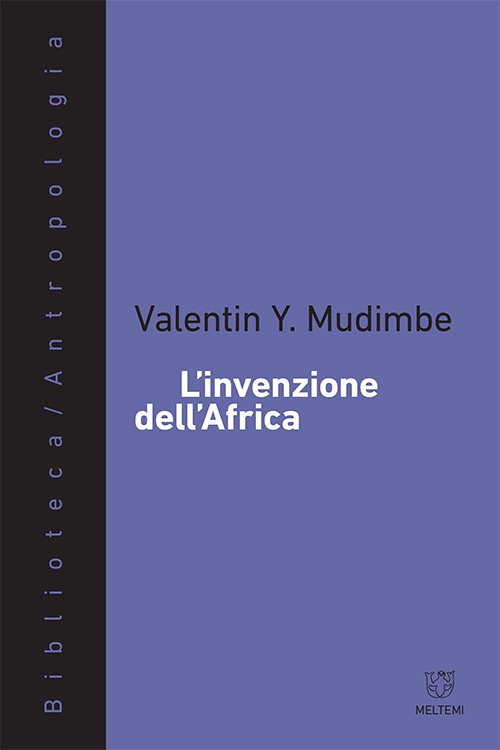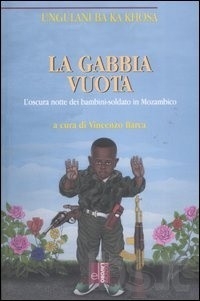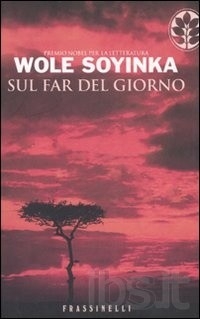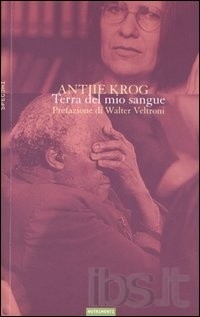Alcuni destini sono particolarmente segnati. Le persone che li hanno in sorte non sanno cosa sia la banalità. Codarde o coraggiose, forti o deboli che siano, i loro difetti e le loro qualità risultano sempre eccezionali. Così è stato per mio fratello, Lem Liam Mianga...Il suo nome da solo era tutto un programma: “costruttore di ponti”. Oggi è un artista di successo, un marito e un padre, ma ha amato e amerà sempre una sola donna: nostra nonna Madjo! Sua moglie lo sa, se n'è fatta una ragione: dopotutto, un essere così bizzarro non poteva che avere sentimenti strani... Di quelli così innominabili, invisi e tenaci che ti fanno finire diritto sul lettino di uno psicanalista, o peggio in manicomio, in prigione, al cimitero, per violazione di tabù, immoralità, anormalità, sovversione dell'ordine pubblico.
La storia straordinaria di chi ha fortemente creduto nell’indipendenza del proprio paese e le cui speranze di cambiamento, schiacciate dalla violenza, dalla sopraffazione e dalla corruzione, trovano nuovo nutrimento nel sapere delle donne e nella potenza rigeneratrice dell’arte.
Leggi di più...