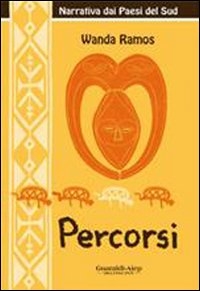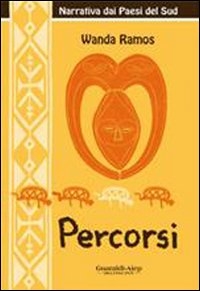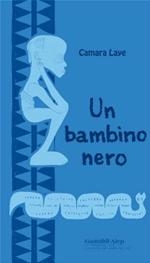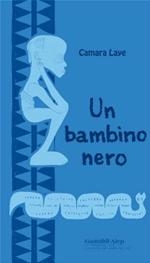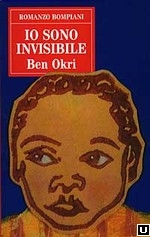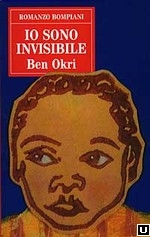District Six
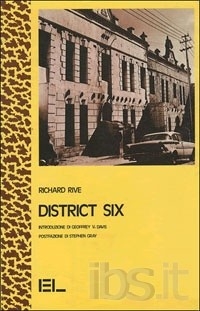
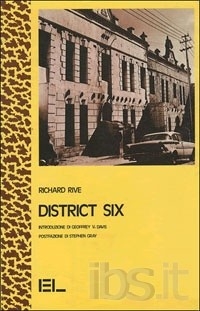

Bibliografia a cura di Paola Montecorboli, Giorgia Del Monte e Ivana Dama
Hanno collaborato Valeria Bersacchi e Anna Maria Coszach.
Consulenti: Maria Antonietta Saracino e Carla Ghezzi.
In Africa è sempre esistita una ricchissima letteratura orale rappresentata da miti, racconti, proverbi, canzoni e poemi epici, cui era demandato il compito di trasmettere storia e valori tradizionali.
Sebbene agli occhi dell’Occidente esista una identità culturale africana che viene percepita come omogenea, come un tutto indistinto, non si può dimenticare che nel continente africano sono presenti popolazioni, lingue e tradizioni diverse.
Già dall’Ottocento, ma con maggior forza a partire dall’inizio del secolo, con la colonizzazione, in varie zone dell’Africa sono nate letterature scritte in lingue differenti, per lo più europee, che da allora accompagnano la storia dell’Africa stessa interpretandone le realtà complesse e conflittuali.
Queste letterature sono state dominate per oltre un ventennio dall’espressione poetica ad opera dei padri della “negritudine”, come Léopold Sédar Senghor, e si sono affermate e sviluppate soprattutto in stretta connessione con la presa di coscienza dell’identità culturale e con gli eventi che dalla metà del secolo in poi hanno condotto gli stati africani all’indipendenza.
Diverse sono state le influenze culturali e linguistiche del colonialismo su queste letterature, spesso indicate come di area anglofona, francofona e lusofona, così come differenti sono stati i processi di appropriazione e di africanizzazione delle lingue europee da parte degli scrittori africani.
In molti casi gli autori hanno modificato la sintassi e il lessico delle lingue imposte dalla colonizzazione, utilizzando ritmi, modalità espressive e sonorità appartenenti alle lingue autoctone, e personaggi attinti dalla tradizione orale.
L’analfabetismo e la scarsa conoscenza delle lingue straniere in cui sono scritte le opere fanno sì che la letteratura africana sia più letta fuori dall’Africa che dagli africani stessi.
In Italia le prime traduzioni di autori africani, che risalgono agli anni cinquanta e sessanta, hanno avuto poca risonanza e solo dagli ultimi anni la letteratura africana è presente sugli scaffali delle nostre librerie in modo significativo.
La più rappresentata è la letteratura anglofona, mentre la letteratura francofona è stata scarsamente tradotta, nonostante il ruolo che ha avuto nella presa di coscienza dell’identità africana.
Gli scrittori di lingua portoghese sono forse stati quelli più trascurati dall’editoria italiana e rare sono le traduzioni dalle lingue autoctone.
Il percorso bibliografico che qui presentiamo, pur non avendo la pretesa di essere esaustivo, vuole aiutare il lettore ad orientarsi all’interno del vasto panorama della letteratura africana tradotta in italiano e vuole essere un invito ad avvicinarsi all’Africa attraverso i suoi scrittori, nella convinzione che la narrativa sia uno dei veicoli più immediati per comprendere realtà complesse e differenti dalla nostra.
Abbiamo voluto segnalare la data in cui i libri sono apparsi in Italia per la prima volta, per permettere al lettore di comprendere il difficile percorso editoriale della letteratura africana.
Molti libri purtroppo risultano esauriti, ma la maggior parte possono essere presi in prestito nelle nostre biblioteche, in alcuni casi in lingua originale, o consultati presso la sezione africana della Biblioteca dell’IsIAO.
Vogliamo infine ringraziare Maria Antonietta Saracino dell’Università di Roma La Sapienza e Carla Ghezzi dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente per la loro preziosa consulenza.
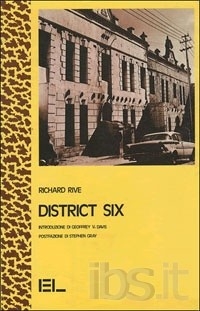
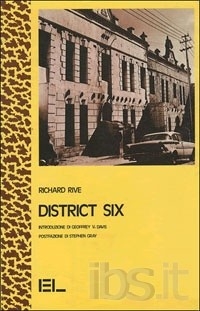


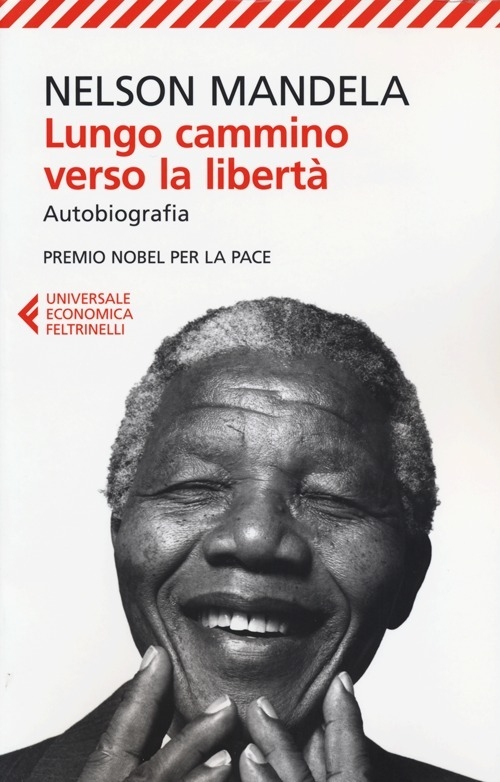
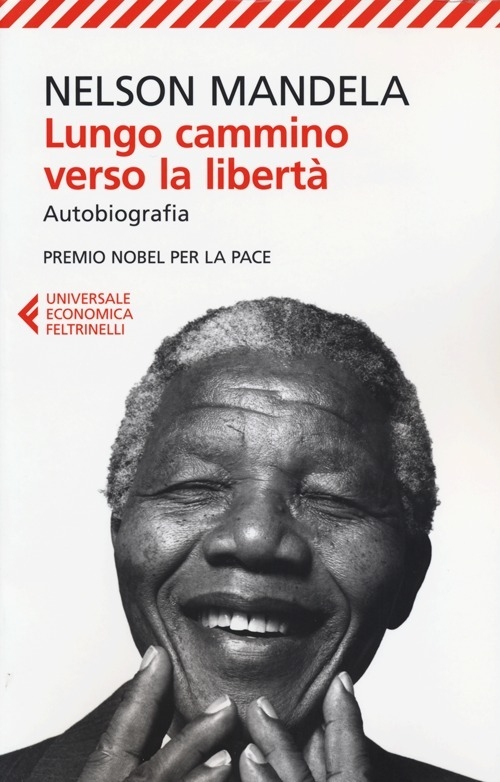
La corposa e appassionante autobiografia di uno dei più grandi leader storici del nostro tempo, ma anche autobiografia di un paese che nelle parole del suo capo riscrive la propria storia.
Mandela, in tono scevro da polemiche e autocompiacimenti, racconta la storia della sua vita in un contrappunto continuo tra dimensione personale e politica.




Narratore, poeta e drammaturgo, l'autore è uno degli scrittori più importanti e originali dell'Africa francofona.
A Valencia, ex capitale di un improbabile stato meticcio, Lorsa Lopez uccide la propria moglie nell’indifferenza degli abitanti, sprofondati nell’apatia e nell’insensibilità. Solo a delitto consumato le donne si rivolteranno.
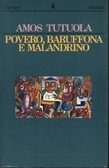
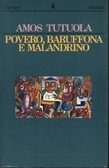
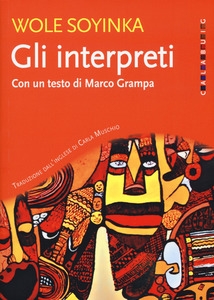
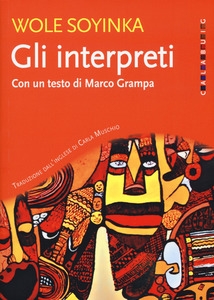
Scritto nel 1965, ritrae la vita di un gruppo di intellettuali rientrati in Nigeria dopo aver compiuto gli studi all'estero, all'indomani dell'indipendenza.
Nel complesso groviglio delle loro esistenze, delle loro preoccupazioni e occupazioni, si riveleranno incapaci di porsi come “interpreti”, di prendere decisioni e di impegnarsi. L’autore, premio Nobel per la letteratura nel 1986, denuncia la profonda crisi morale che attraversa i regimi nati dalle indipendenze.


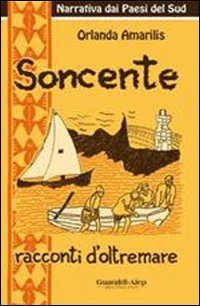
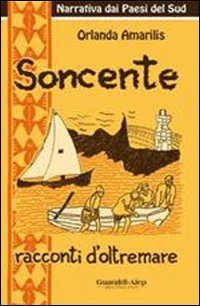
Seguendo i moduli del racconto orale e le suggestioni delle credenze popolari, l'autrice ci introduce nell'insolito universo dell'arcipelago di Capo Verde.
Un ritratto di donne vitali e coraggiose, spesso costrette dalle siccità ricorrenti ad un adattamento ai limiti della sopravvivenza, o spinte alla scelta dell’emigrazione nella speranza di una vita migliore.
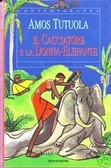
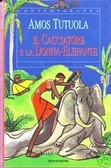
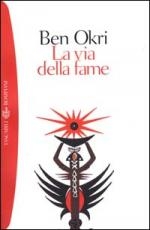
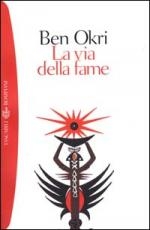


Romanzo autobiografico, storia di un'infanzia e di un'iniziazione alla vita, del passaggio al mondo degli adulti, dalla vita del villaggio alla realtà urbana e alla cultura occidentale.
L’autore fonde il substrato mitico della realtà africana con uno sguardo attento ai misteri della natura e ai rapporti interpersonali all’interno della comunità.