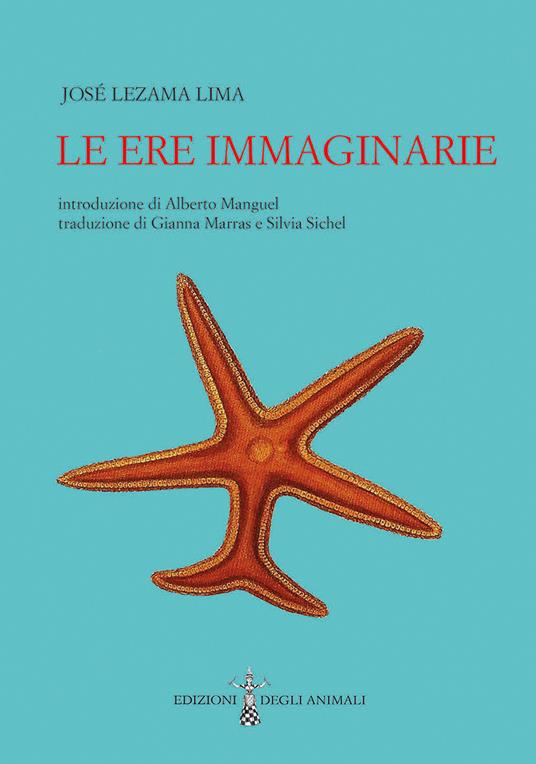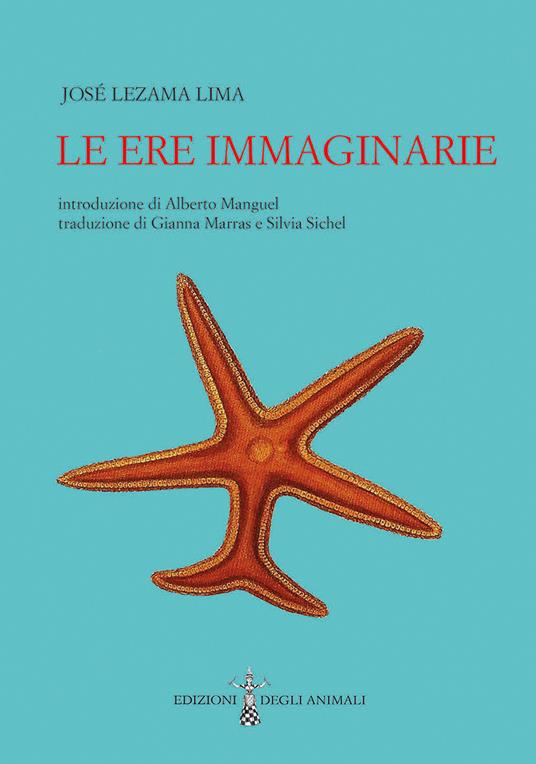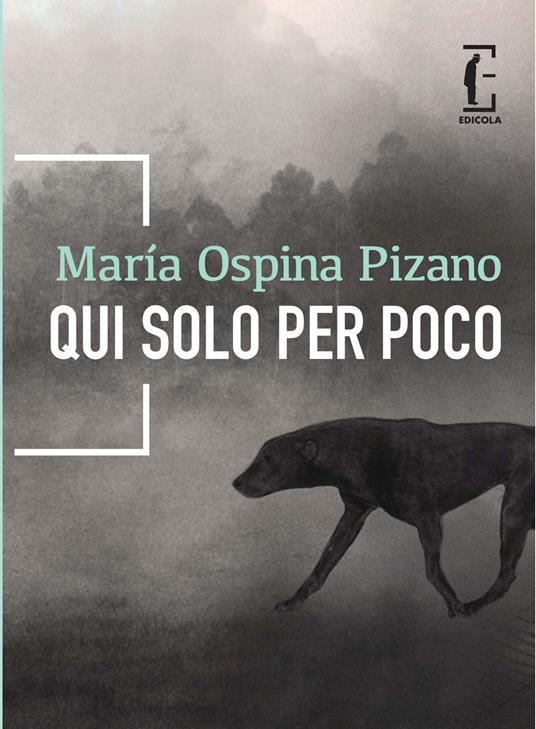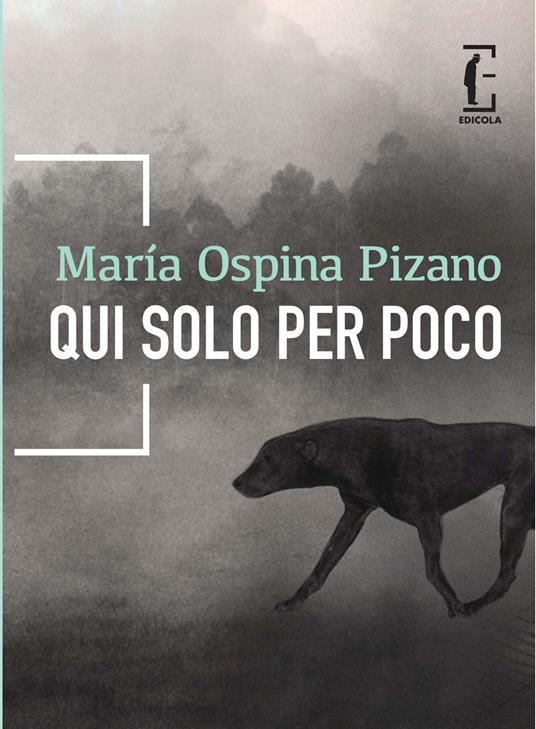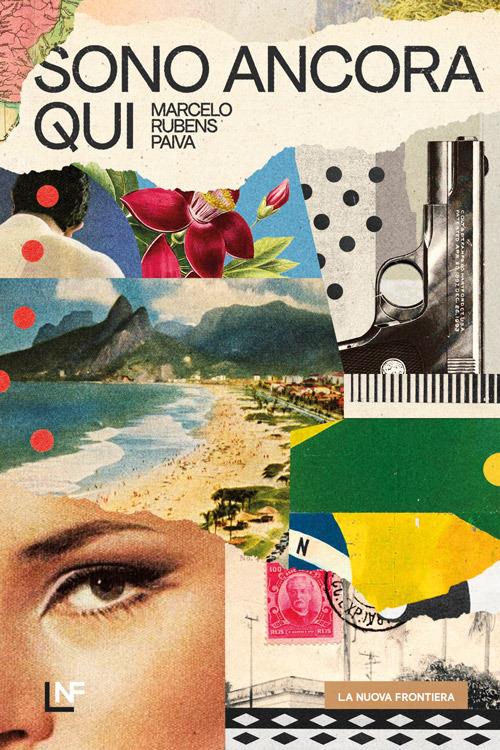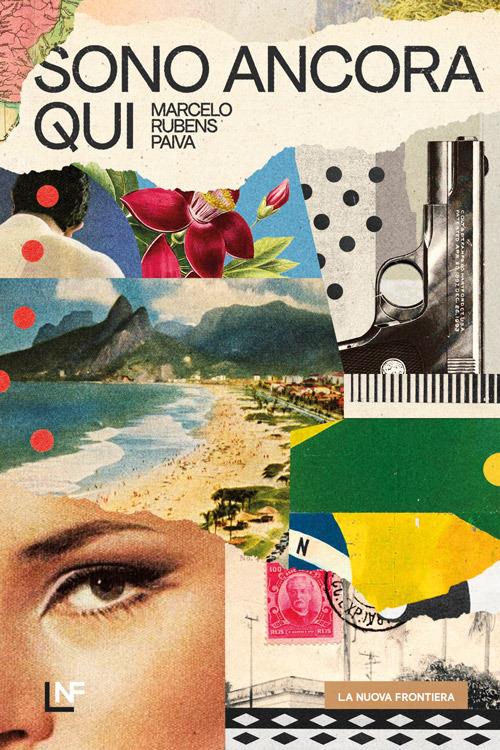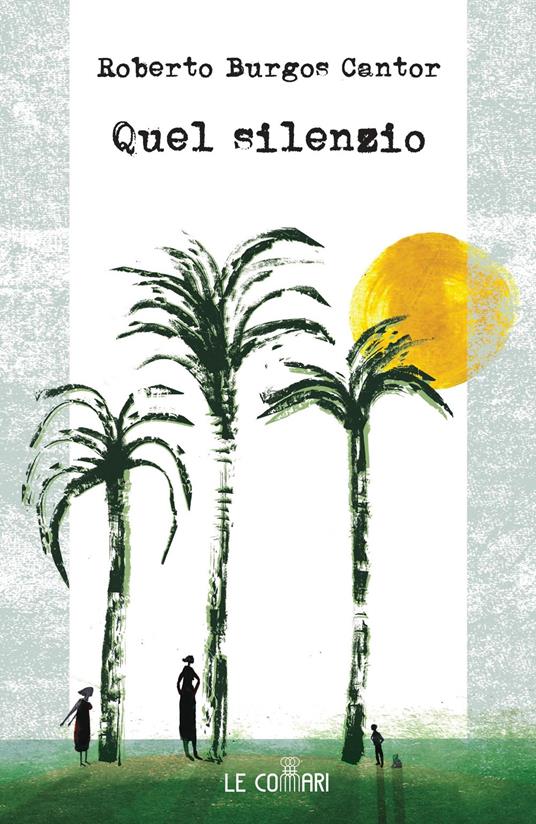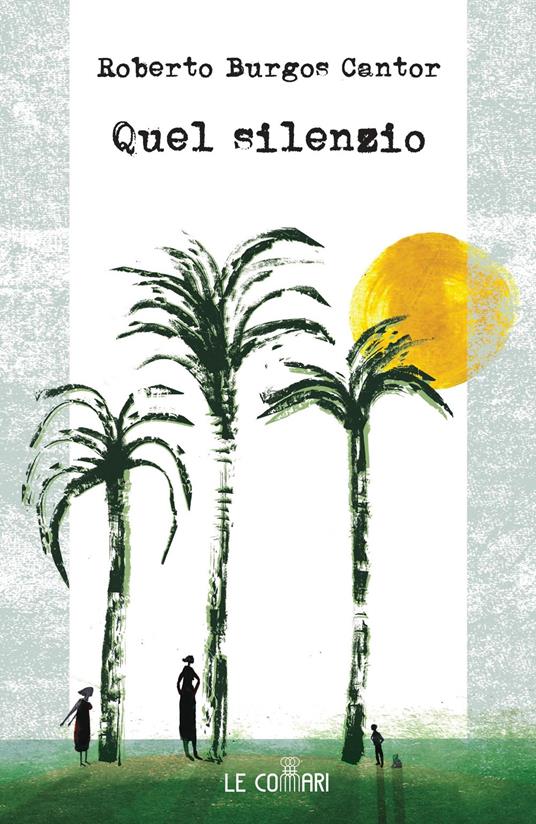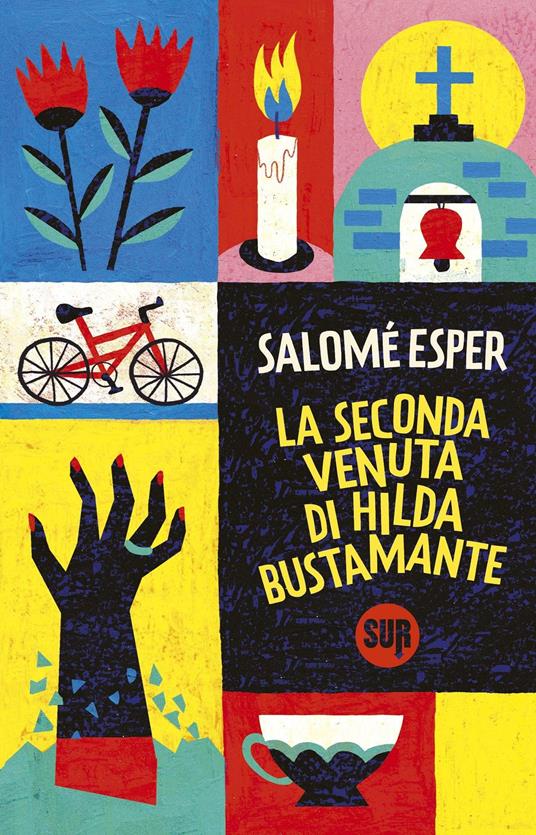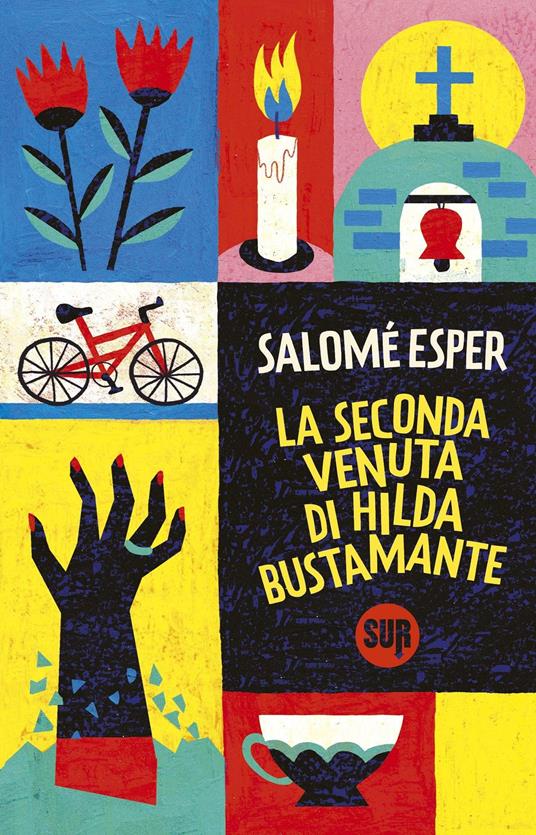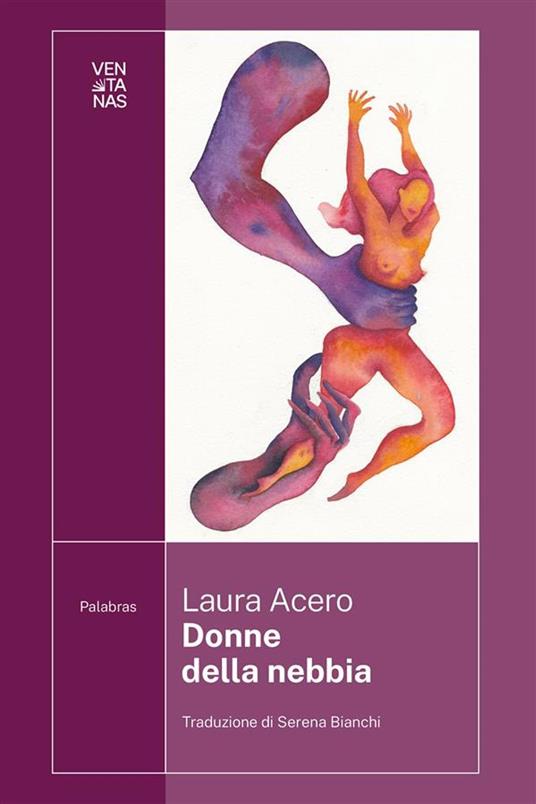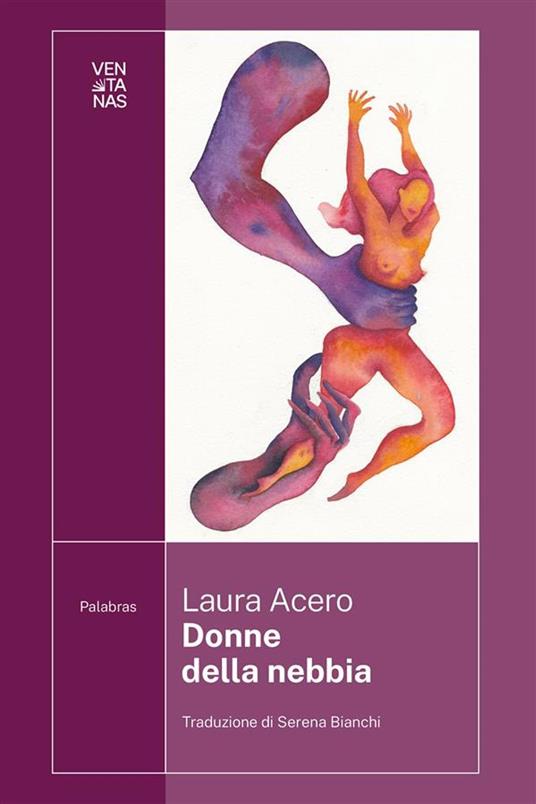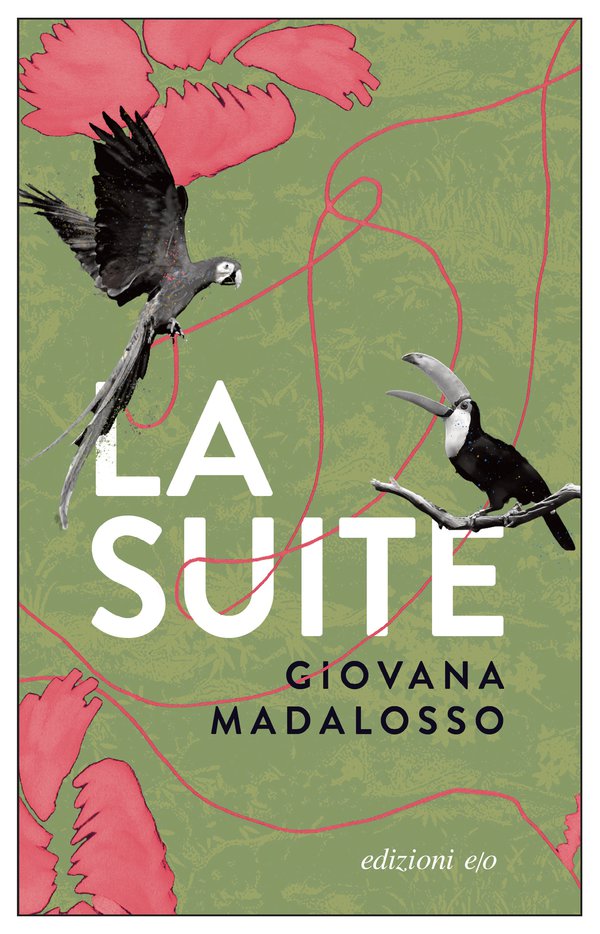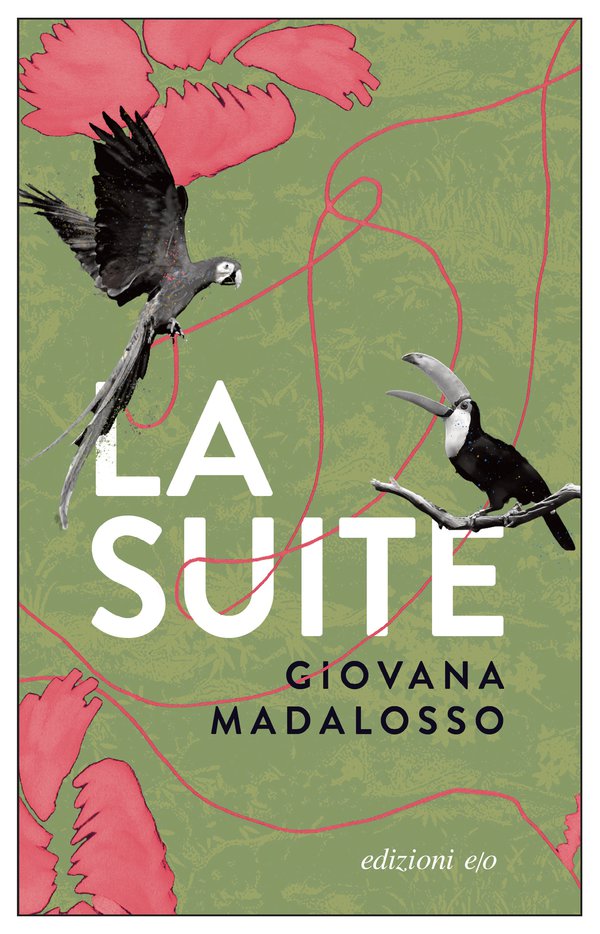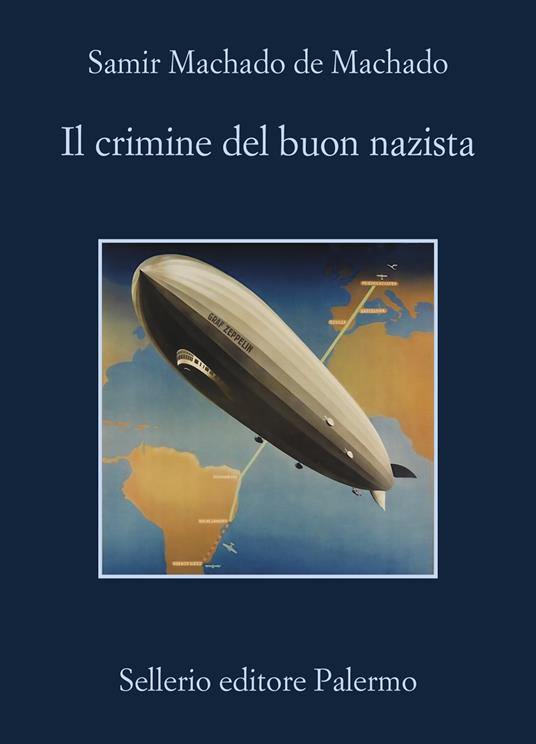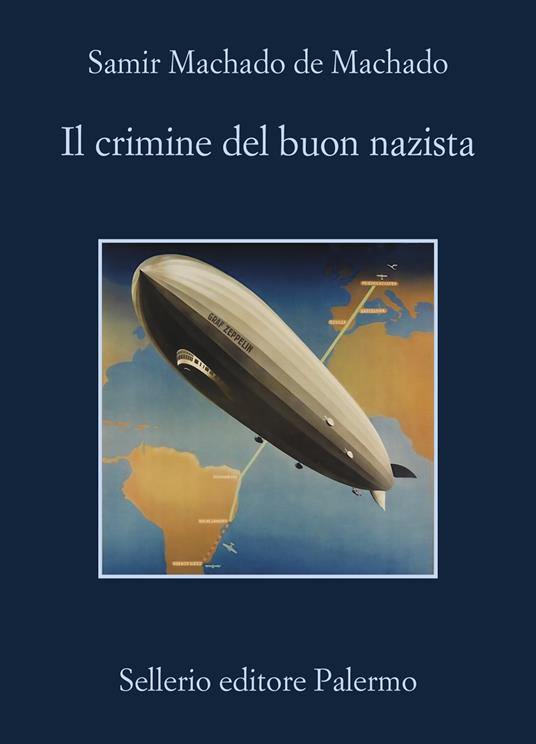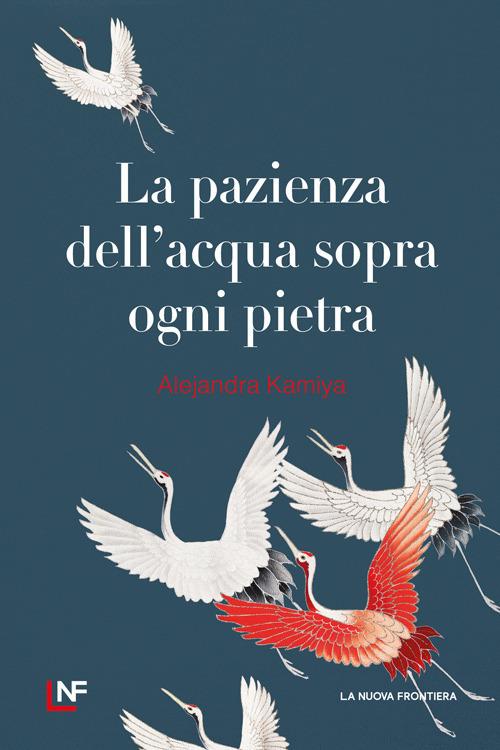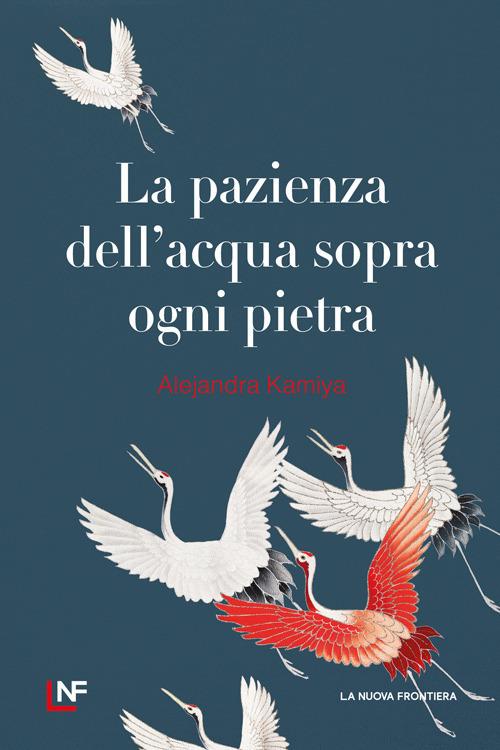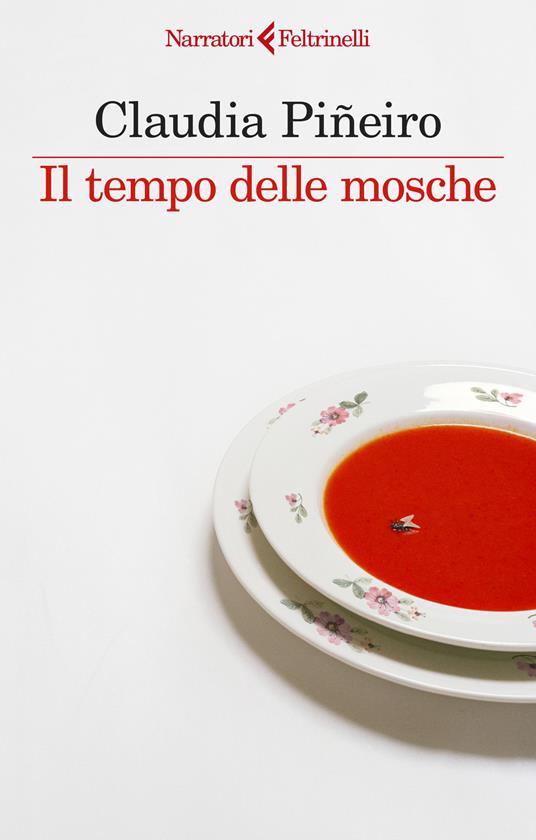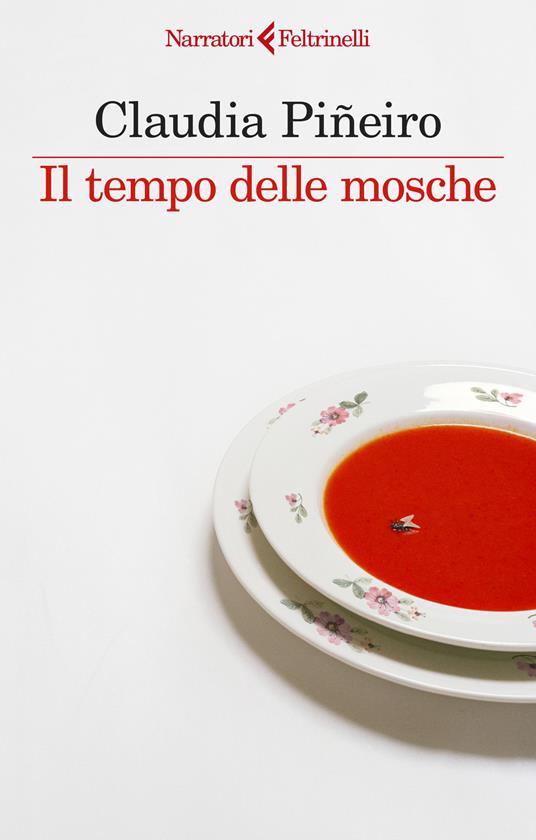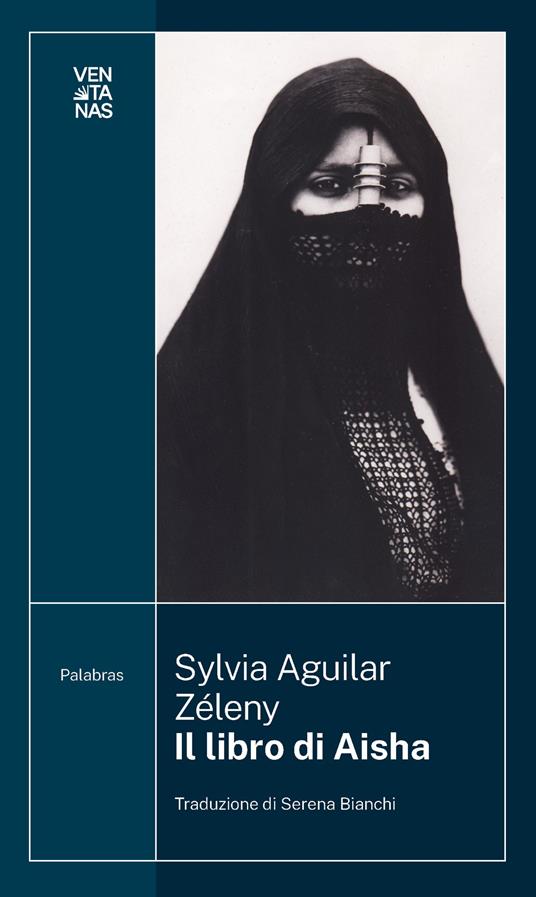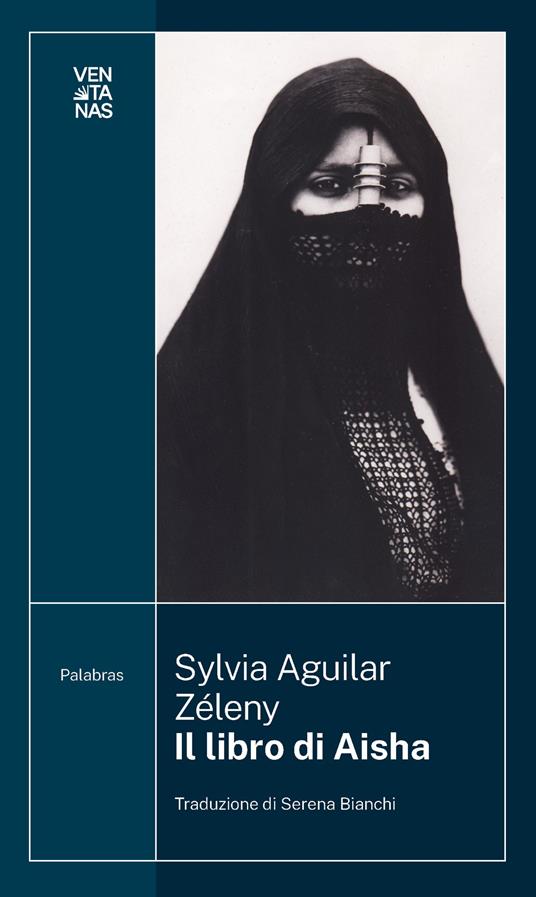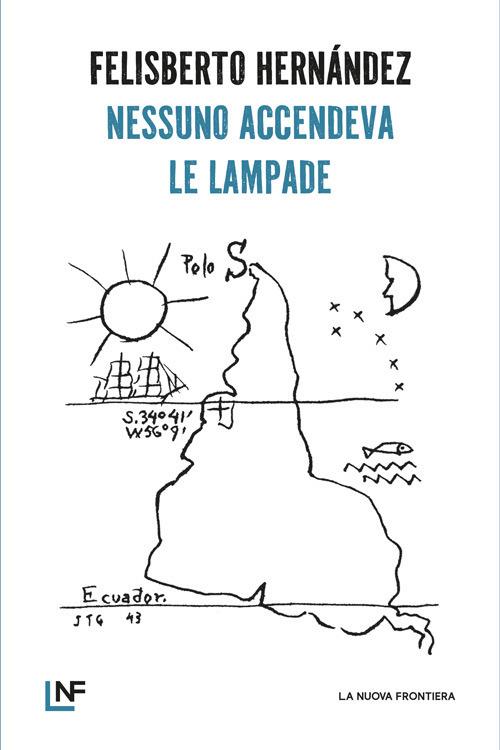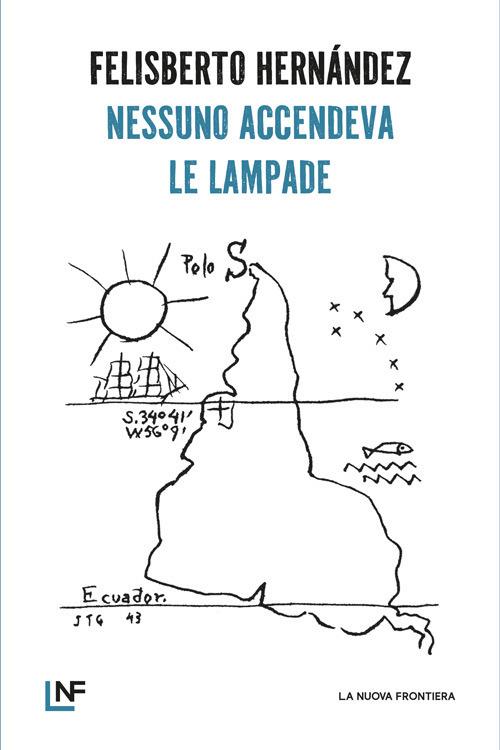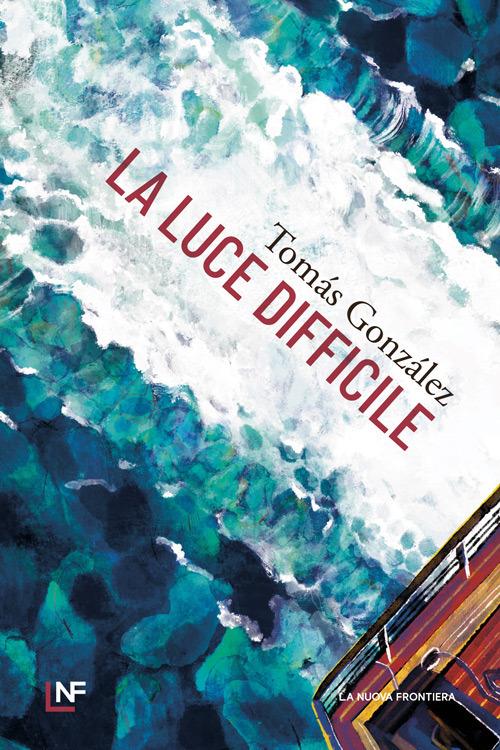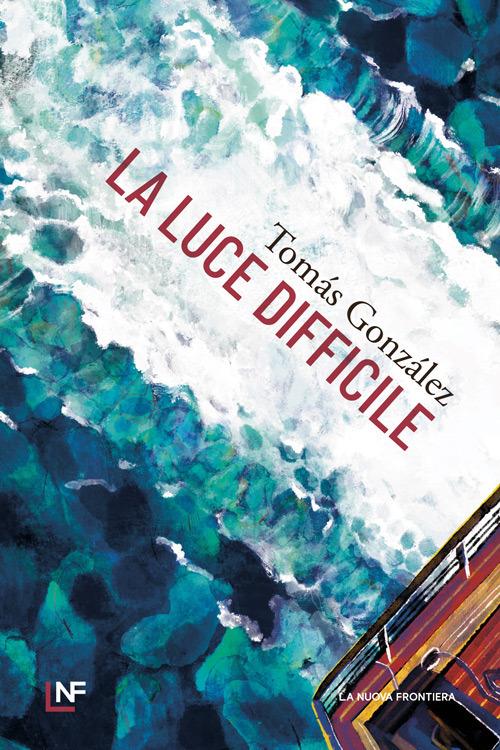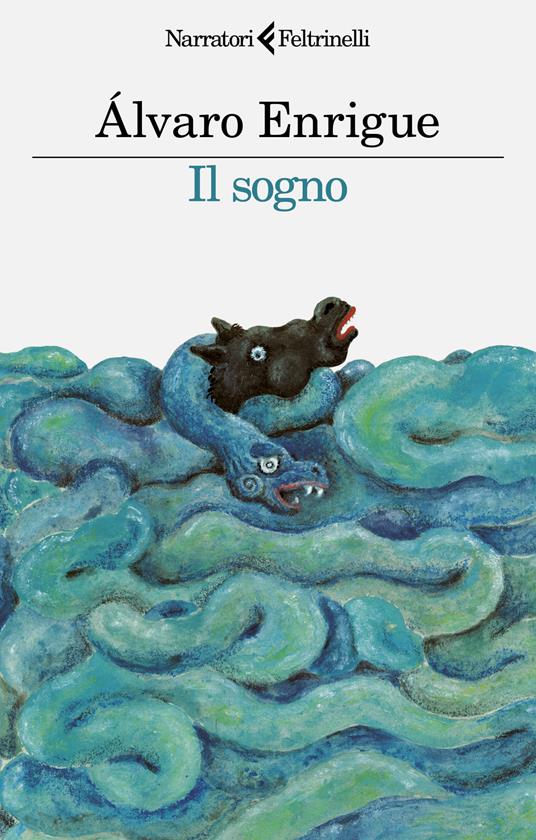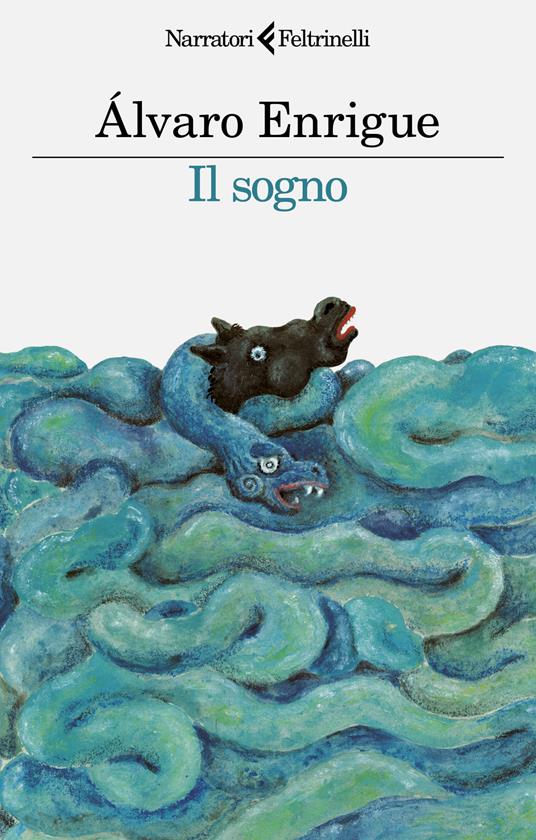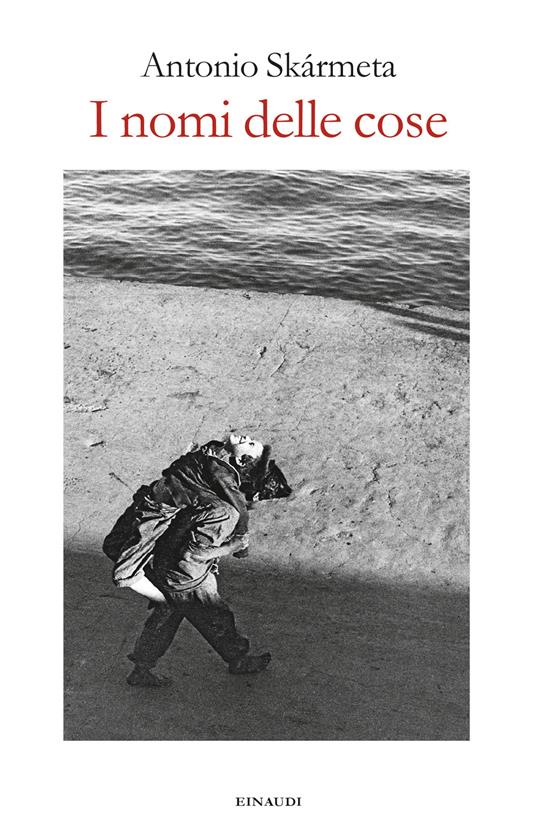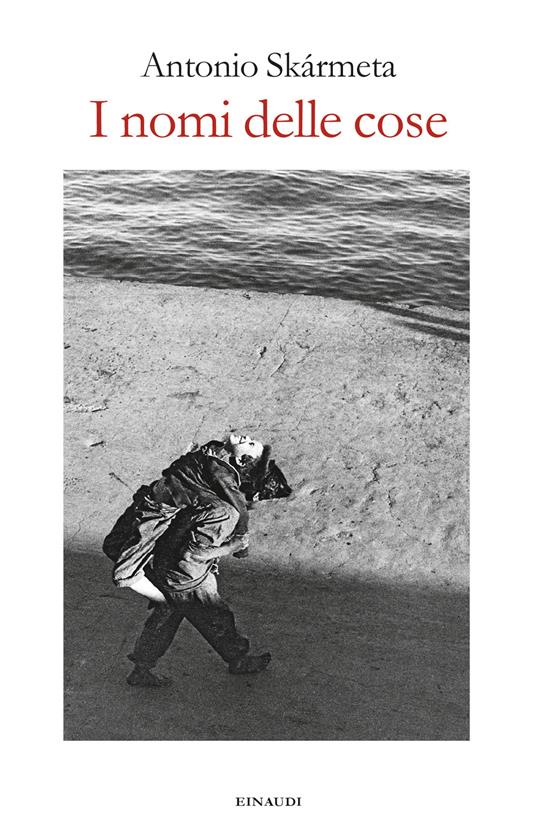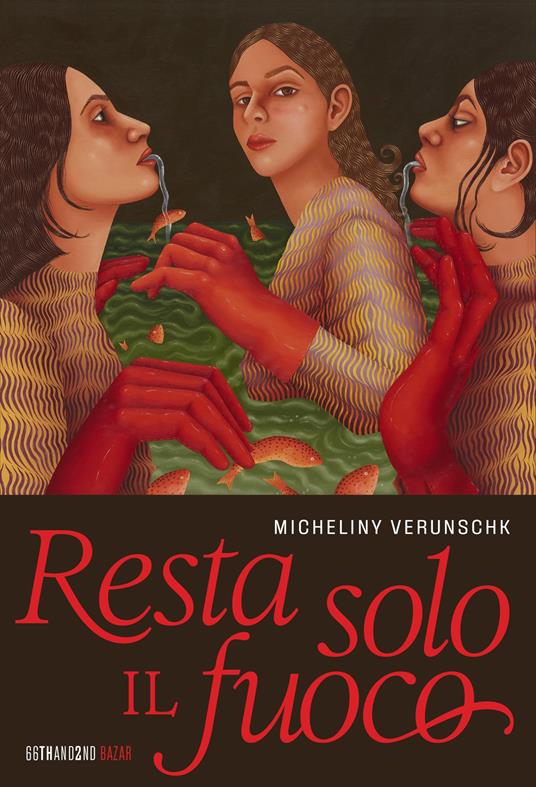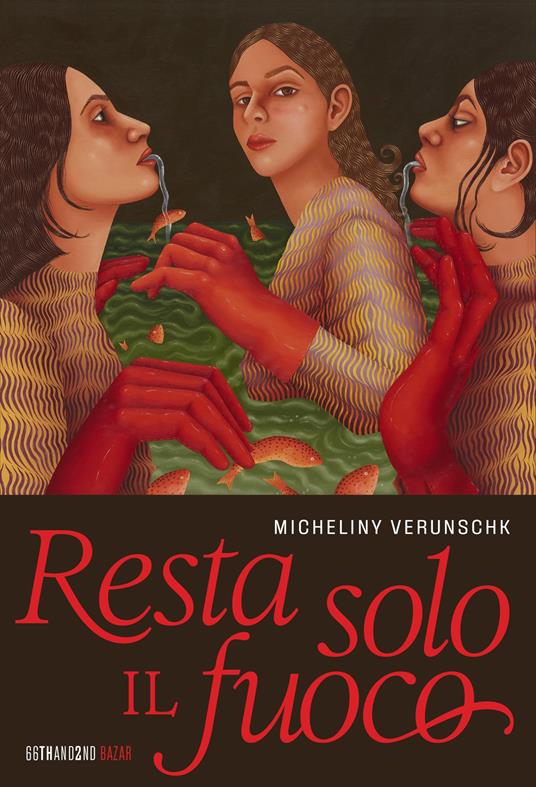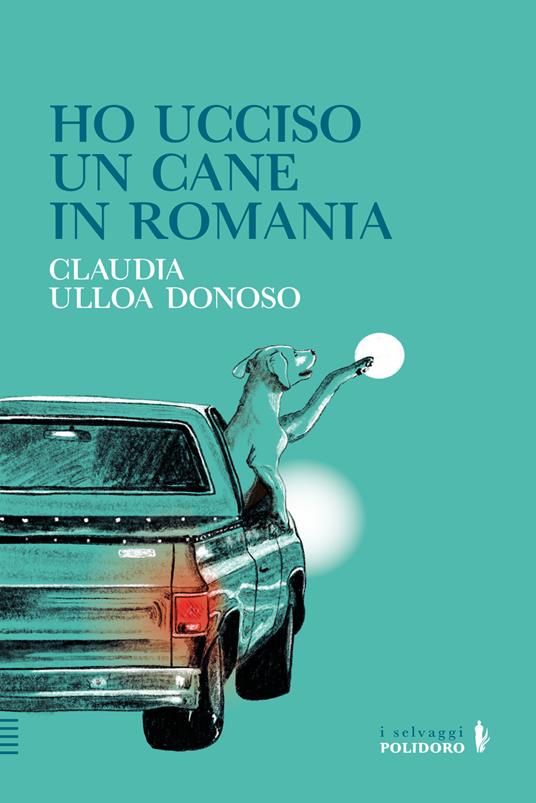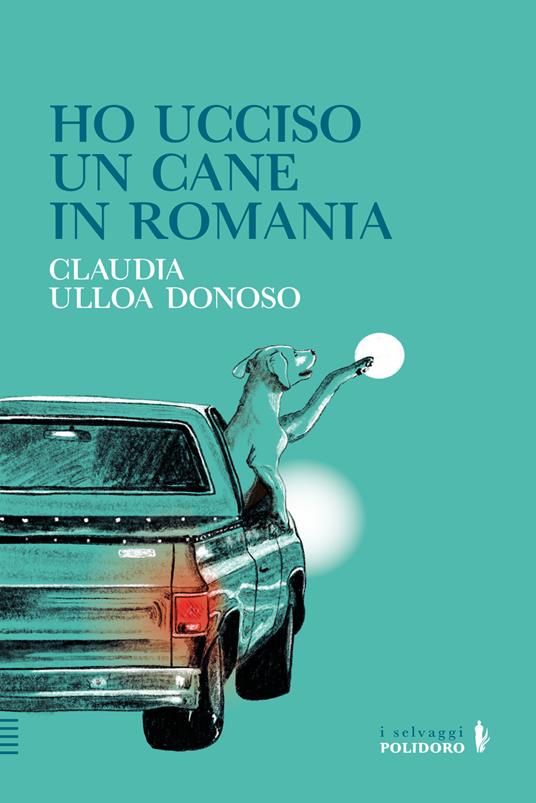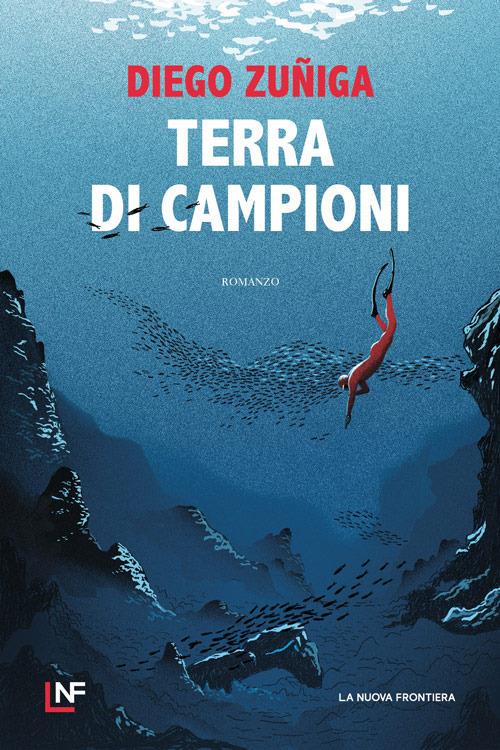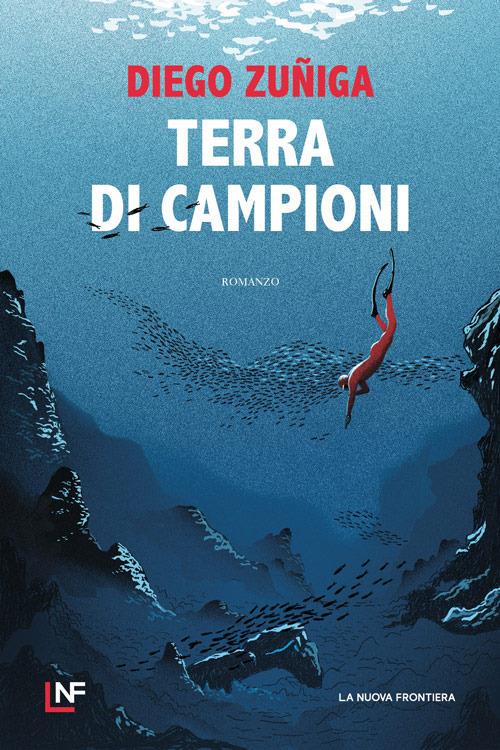Le ere immaginarie
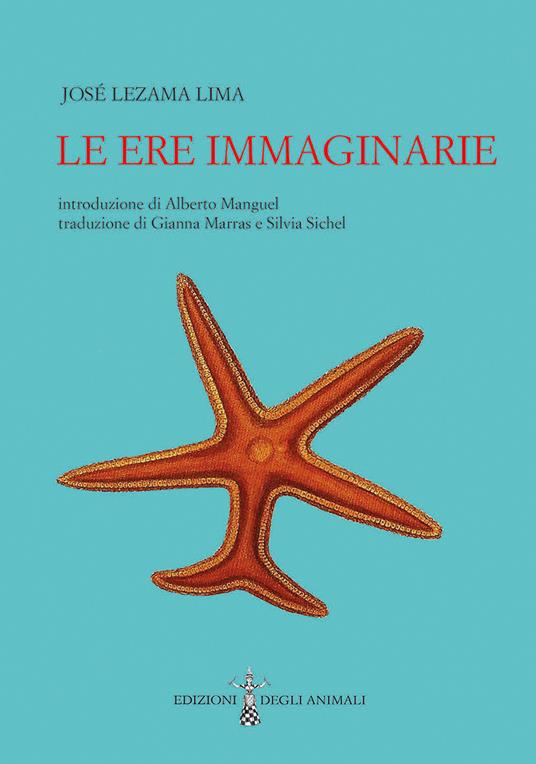
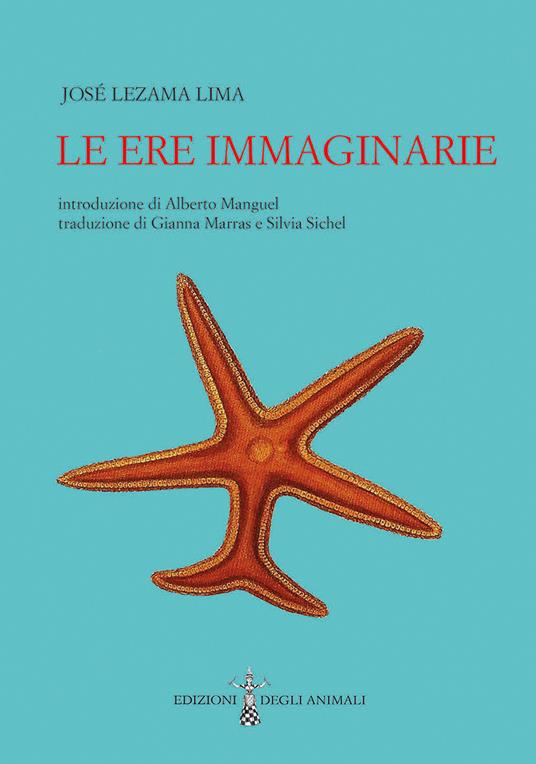

Introduzione e bibliografia a cura di Leila Djalali
Quando parliamo di letteratura francese, inglese, o spagnola, il nostro pensiero va direttamente ad un singolo paese, che ha dei tratti culturali comuni, dalla storia, fino ad arrivare alla cucina e alla musica.
Se pensiamo ad un intero continente, come si fa, ad esempio, per l‘Africa, siamo, o perlomeno, dovremmo essere consapevoli, che al suo interno esistono delle differenze; basti pensare alla religione, alla lingua, agli usi e costumi. Tutte rientrano comunque sotto lo stesso nome: Africa.
Se invece ci riferiamo all’America Latina, la questione del nome diventa più complessa.
La storia di questo immenso territorio, che va dal Messico alla Terra del Fuoco, passando per le altissime vette delle Ande peruviane, ma anche per la foresta amazzonica e le sterminate pampas argentine, non inizia certo nel 1492, con l’arrivo di Cristoforo Colombo, né nel 1519, anno in cui uno spagnolo, Hernán Cortés, entra in Messico e si rende conto che nelle terre che avevano da poco scoperto, non esistevano solamente piccoli villaggi poco organizzati, ma potenti e vasti imperi.
La denominazione “America Latina”, quindi, può essere funzionale per noi europei se si usa per distinguerla dall’America Settentrionale, anglosassone; ma non tiene conto della componente indigena, ossia di quelle popolazioni di origine asiatica che decine di migliaia di anni fa attraversarono lo stretto di Bering e si stabilirono in questo continente; inoltre, esclude tutta una Afroamerica che invece esiste, nella letteratura, ma anche nella musica, nella danza, nei rituali religiosi.
Faremo rientrare in questa bibliografia, quindi, non solamente le opere di narrativa latinoamericana, ormai molto famose qui in Italia grazie al boom degli anni ‘60, che ha reso visibili all’Europa (ma anche all’America stessa, ora consapevole di costituire una realtà unica sotto vari punti di vista) scrittori come il colombiano Gabriel García Márquez, il brasiliano Jorge Amado, gli argentini Manuel Puig e Julio Cortázar, il peruviano Mario Vargas Llosa.
Faremo rientrare anche opere che possano allargare i nostri orizzonti fino alle antiche credenze e leggende pre-colombiane, raccolte dai vari ordini religiosi che, subito dopo la Conquista, si recarono in America a diffondere il cattolicesimo; fra queste, il Popol Vuh, la cosiddetta “bibbia maya”, una raccolta di leggende, miti e tradizioni di una delle più fiorenti civiltà esistenti in America prima dell’arrivo degli europei. Oppure i diari di Cristoforo Colombo, dove tante volte si legge la parola “meraviglia”, unica in grado di esprimere lo stupore e l’estasi provata da chi per primo mise piede in questo sorprendente territorio, dove a volte la realtà sembra superare la fantasia.
Abbiamo cercato di includere anche scrittori meno conosciuti qui in Italia, ma molto importanti in America Latina, che hanno contribuito a rendere coerente, se non a creare, quella “identità latinoamericana” su cui sono state scritte moltissime pagine e su cui ancora oggi si continua a discutere. Quell’identità caratterizzata dal dualismo fra civiltà e barbarie, di cui parla nel suo saggio l’argentino Sarmiento, in cui tutto ciò che in America fosse considerato negativo veniva identificato con la selva, mentre il polo positivo era rappresentato dalla città, dall’Europa, dalla modernità.
Da allora, molti altri intellettuali e scrittori latinoamericani hanno concentrato la loro attenzione su questo tema, ma la polarizzazione è andata col tempo attenuandosi, fino ad arrivare a capovolgersi e a vedere la foresta come un luogo paradisiaco, in cui l’uomo latinoamericano può ritrovare le proprie radici, la propria originalità.
Includeremo quindi titoli come La voragine, di José Eustasio Rivera (colombiano), in cui il protagonista si muove all’interno di una foresta infernale, che divora inevitabilmente tutti coloro che cerchino di entrarvi e, sul polo opposto, I passi perduti, del cubano Alejo Carpentier, un viaggio verso l’interno del paese che si trasformerà in un viaggio nel tempo, fino a raggiungere un’epoca precedente a quella della Genesi.
Nelle letture che vi proponiamo, inoltre, troverete romanzi incentrati sulla figura del gaucho, l’abitante della pampa argentina che, dopo essere stato a lungo rigettato ed eliminato dalla cultura dominante, è stato mitizzato dalla letteratura in opere come Don Segundo Sombra di Ricardo Güiraldes.
Oppure romanzi che, con un duplice intento letterario e di denuncia sociale, ruotano intorno alla figura dell’indigeno, dapprima per rappresentare la sua condizione di sfruttato, poi per dar voce a questa componente della cultura latinoamericana che non può essere dimenticata.
Molto interessanti, oltre che numerosi, sono anche i romanzi che hanno come tema quello della dittatura, trattato da scrittori provenienti da ogni parte del continente; fra questi, Gabriel García Márquez, che in L’autunno del patriarca dà vita a un dittatore onnisciente e onnipresente, che solo alla fine dei suoi giorni si renderà conto che la sua immortalità era solo un’illusione.
Cercando di non escludere le novità letterarie, né tutti quei titoli da cui sono stati tratti bellissimi film, come Il bacio della donna ragno dell’argentino Hector Babenco, oppure Fragola e cioccolato, del messicano Juan Carlos Tabio, vi proponiamo una bibliografia che non pretende di essere completa, ma tiene conto dei principali fenomeni sociali e culturali che hanno caratterizzato l’America Latina nel corso del XX secolo.