Stupore indigeno
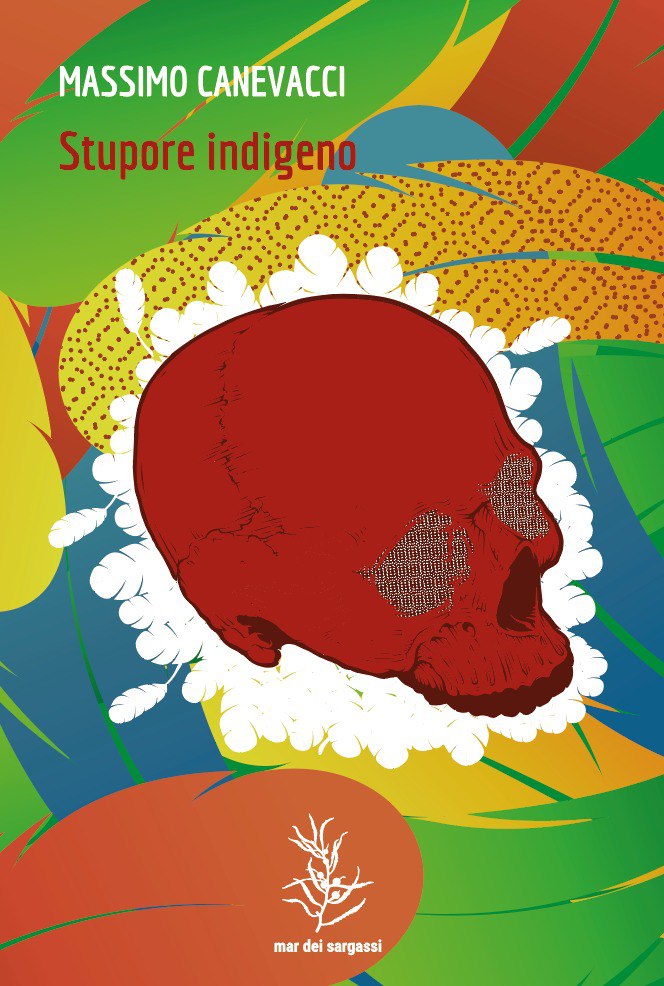
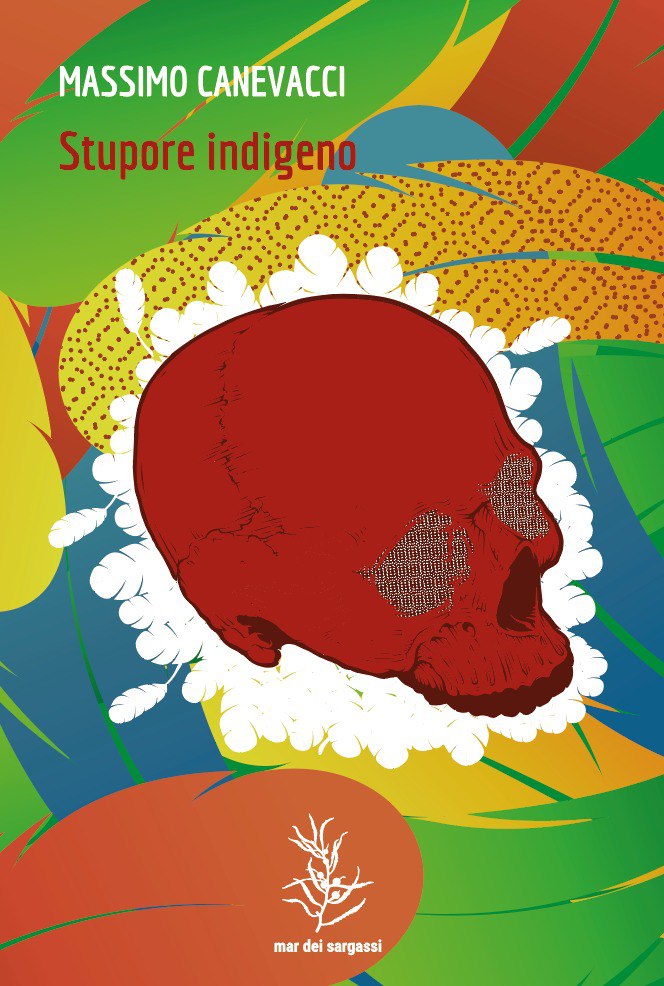

Introduzione e bibliografia a cura di Leila Djalali
Quando parliamo di letteratura francese, inglese, o spagnola, il nostro pensiero va direttamente ad un singolo paese, che ha dei tratti culturali comuni, dalla storia, fino ad arrivare alla cucina e alla musica.
Se pensiamo ad un intero continente, come si fa, ad esempio, per l‘Africa, siamo, o perlomeno, dovremmo essere consapevoli, che al suo interno esistono delle differenze; basti pensare alla religione, alla lingua, agli usi e costumi. Tutte rientrano comunque sotto lo stesso nome: Africa.
Se invece ci riferiamo all’America Latina, la questione del nome diventa più complessa.
La storia di questo immenso territorio, che va dal Messico alla Terra del Fuoco, passando per le altissime vette delle Ande peruviane, ma anche per la foresta amazzonica e le sterminate pampas argentine, non inizia certo nel 1492, con l’arrivo di Cristoforo Colombo, né nel 1519, anno in cui uno spagnolo, Hernán Cortés, entra in Messico e si rende conto che nelle terre che avevano da poco scoperto, non esistevano solamente piccoli villaggi poco organizzati, ma potenti e vasti imperi.
La denominazione “America Latina”, quindi, può essere funzionale per noi europei se si usa per distinguerla dall’America Settentrionale, anglosassone; ma non tiene conto della componente indigena, ossia di quelle popolazioni di origine asiatica che decine di migliaia di anni fa attraversarono lo stretto di Bering e si stabilirono in questo continente; inoltre, esclude tutta una Afroamerica che invece esiste, nella letteratura, ma anche nella musica, nella danza, nei rituali religiosi.
Faremo rientrare in questa bibliografia, quindi, non solamente le opere di narrativa latinoamericana, ormai molto famose qui in Italia grazie al boom degli anni ‘60, che ha reso visibili all’Europa (ma anche all’America stessa, ora consapevole di costituire una realtà unica sotto vari punti di vista) scrittori come il colombiano Gabriel García Márquez, il brasiliano Jorge Amado, gli argentini Manuel Puig e Julio Cortázar, il peruviano Mario Vargas Llosa.
Faremo rientrare anche opere che possano allargare i nostri orizzonti fino alle antiche credenze e leggende pre-colombiane, raccolte dai vari ordini religiosi che, subito dopo la Conquista, si recarono in America a diffondere il cattolicesimo; fra queste, il Popol Vuh, la cosiddetta “bibbia maya”, una raccolta di leggende, miti e tradizioni di una delle più fiorenti civiltà esistenti in America prima dell’arrivo degli europei. Oppure i diari di Cristoforo Colombo, dove tante volte si legge la parola “meraviglia”, unica in grado di esprimere lo stupore e l’estasi provata da chi per primo mise piede in questo sorprendente territorio, dove a volte la realtà sembra superare la fantasia.
Abbiamo cercato di includere anche scrittori meno conosciuti qui in Italia, ma molto importanti in America Latina, che hanno contribuito a rendere coerente, se non a creare, quella “identità latinoamericana” su cui sono state scritte moltissime pagine e su cui ancora oggi si continua a discutere. Quell’identità caratterizzata dal dualismo fra civiltà e barbarie, di cui parla nel suo saggio l’argentino Sarmiento, in cui tutto ciò che in America fosse considerato negativo veniva identificato con la selva, mentre il polo positivo era rappresentato dalla città, dall’Europa, dalla modernità.
Da allora, molti altri intellettuali e scrittori latinoamericani hanno concentrato la loro attenzione su questo tema, ma la polarizzazione è andata col tempo attenuandosi, fino ad arrivare a capovolgersi e a vedere la foresta come un luogo paradisiaco, in cui l’uomo latinoamericano può ritrovare le proprie radici, la propria originalità.
Includeremo quindi titoli come La voragine, di José Eustasio Rivera (colombiano), in cui il protagonista si muove all’interno di una foresta infernale, che divora inevitabilmente tutti coloro che cerchino di entrarvi e, sul polo opposto, I passi perduti, del cubano Alejo Carpentier, un viaggio verso l’interno del paese che si trasformerà in un viaggio nel tempo, fino a raggiungere un’epoca precedente a quella della Genesi.
Nelle letture che vi proponiamo, inoltre, troverete romanzi incentrati sulla figura del gaucho, l’abitante della pampa argentina che, dopo essere stato a lungo rigettato ed eliminato dalla cultura dominante, è stato mitizzato dalla letteratura in opere come Don Segundo Sombra di Ricardo Güiraldes.
Oppure romanzi che, con un duplice intento letterario e di denuncia sociale, ruotano intorno alla figura dell’indigeno, dapprima per rappresentare la sua condizione di sfruttato, poi per dar voce a questa componente della cultura latinoamericana che non può essere dimenticata.
Molto interessanti, oltre che numerosi, sono anche i romanzi che hanno come tema quello della dittatura, trattato da scrittori provenienti da ogni parte del continente; fra questi, Gabriel García Márquez, che in L’autunno del patriarca dà vita a un dittatore onnisciente e onnipresente, che solo alla fine dei suoi giorni si renderà conto che la sua immortalità era solo un’illusione.
Cercando di non escludere le novità letterarie, né tutti quei titoli da cui sono stati tratti bellissimi film, come Il bacio della donna ragno dell’argentino Hector Babenco, oppure Fragola e cioccolato, del messicano Juan Carlos Tabio, vi proponiamo una bibliografia che non pretende di essere completa, ma tiene conto dei principali fenomeni sociali e culturali che hanno caratterizzato l’America Latina nel corso del XX secolo.
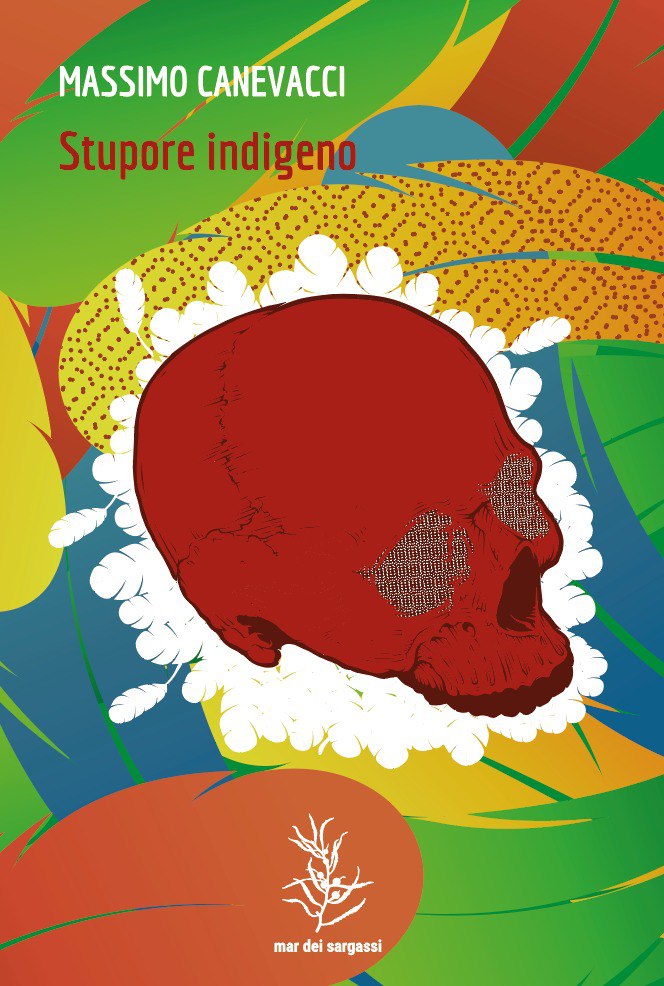
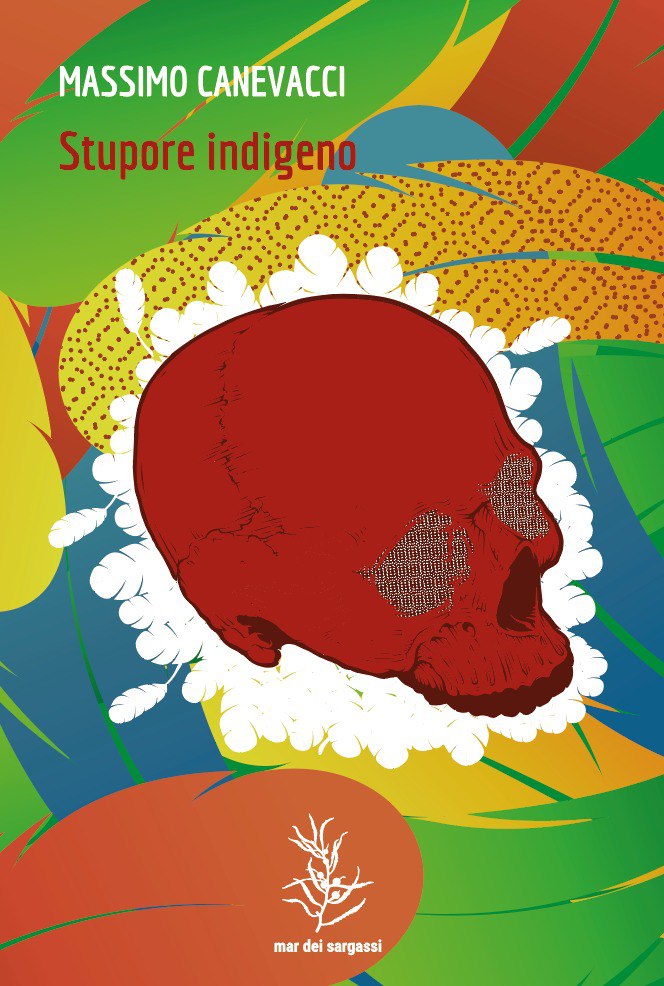
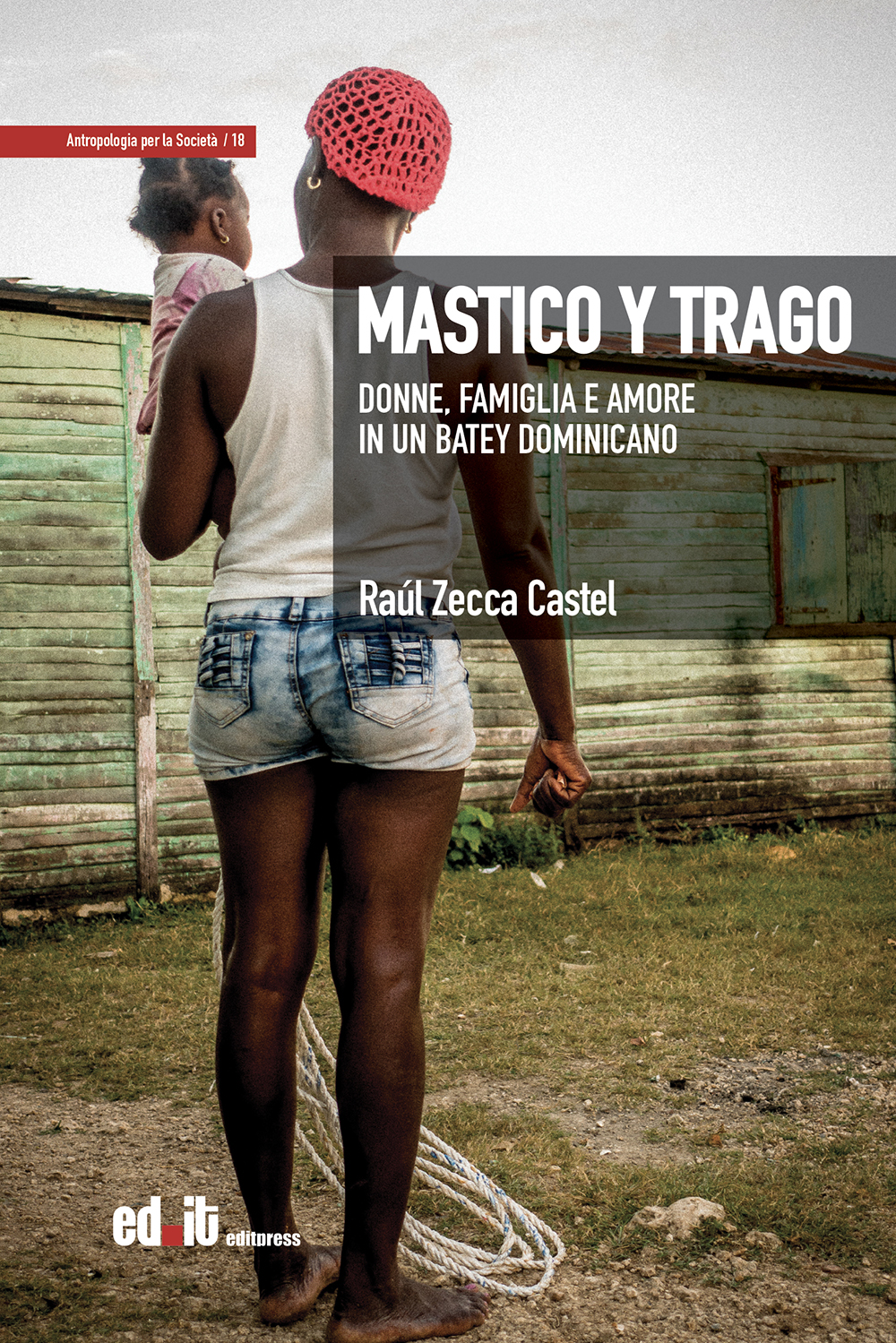
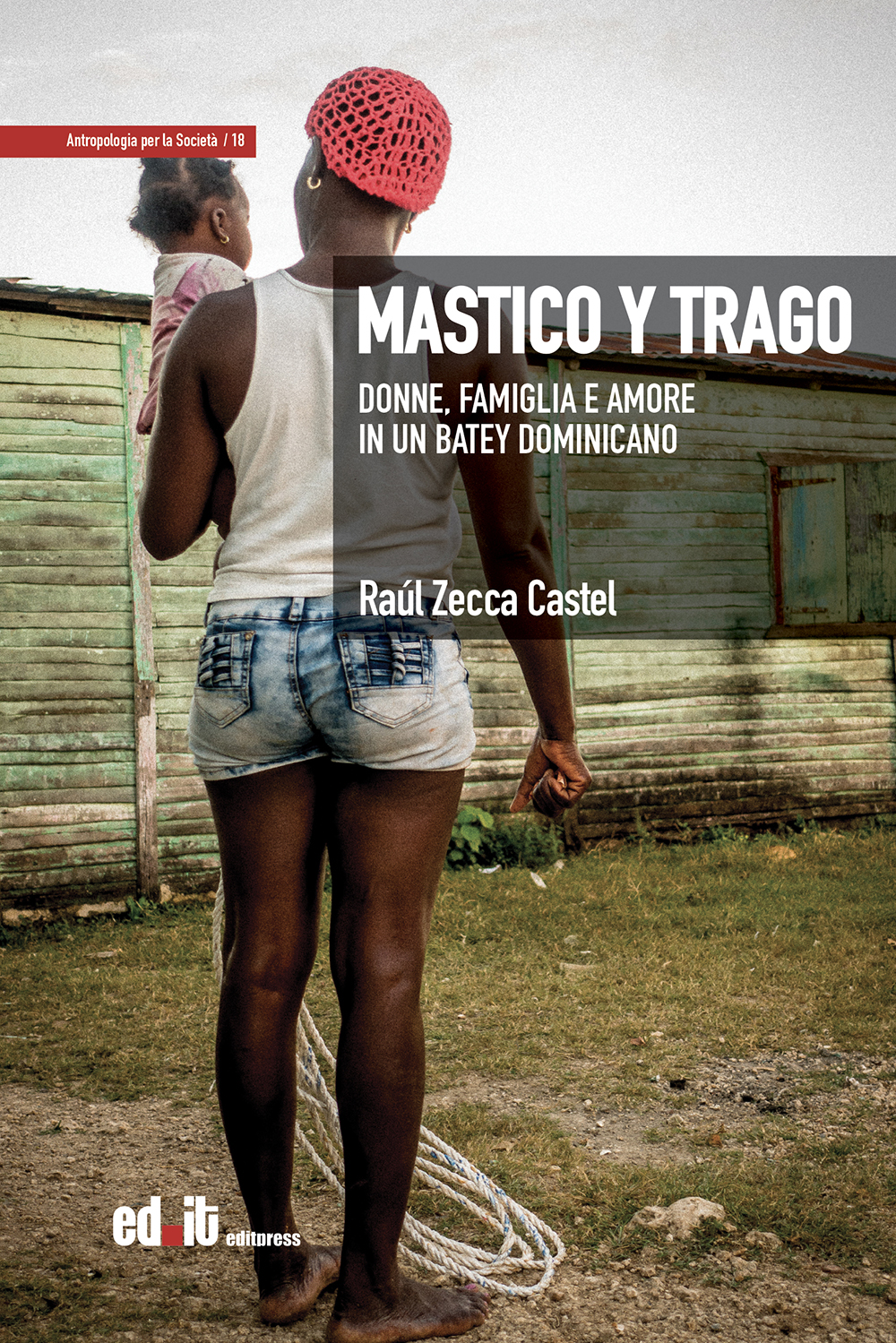
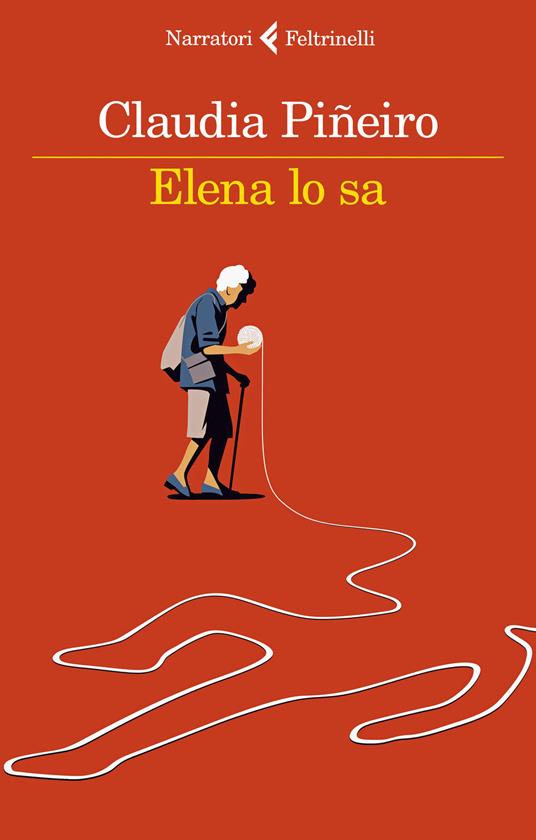
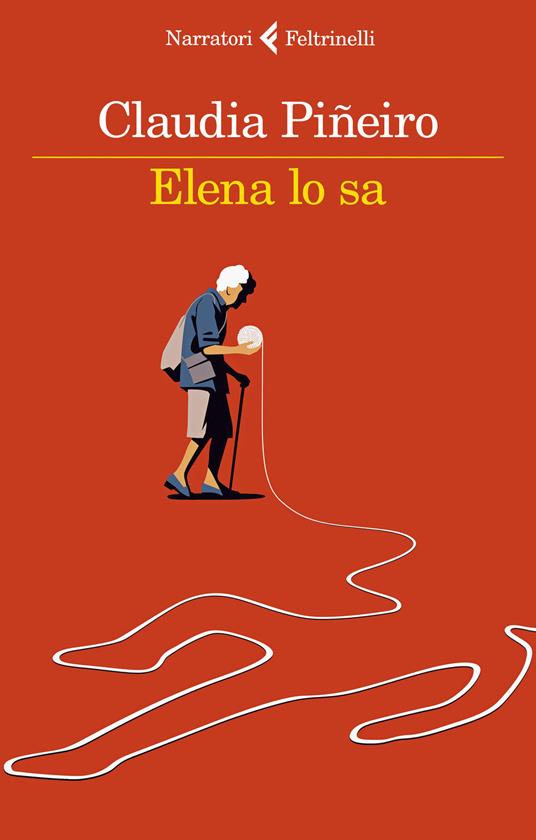
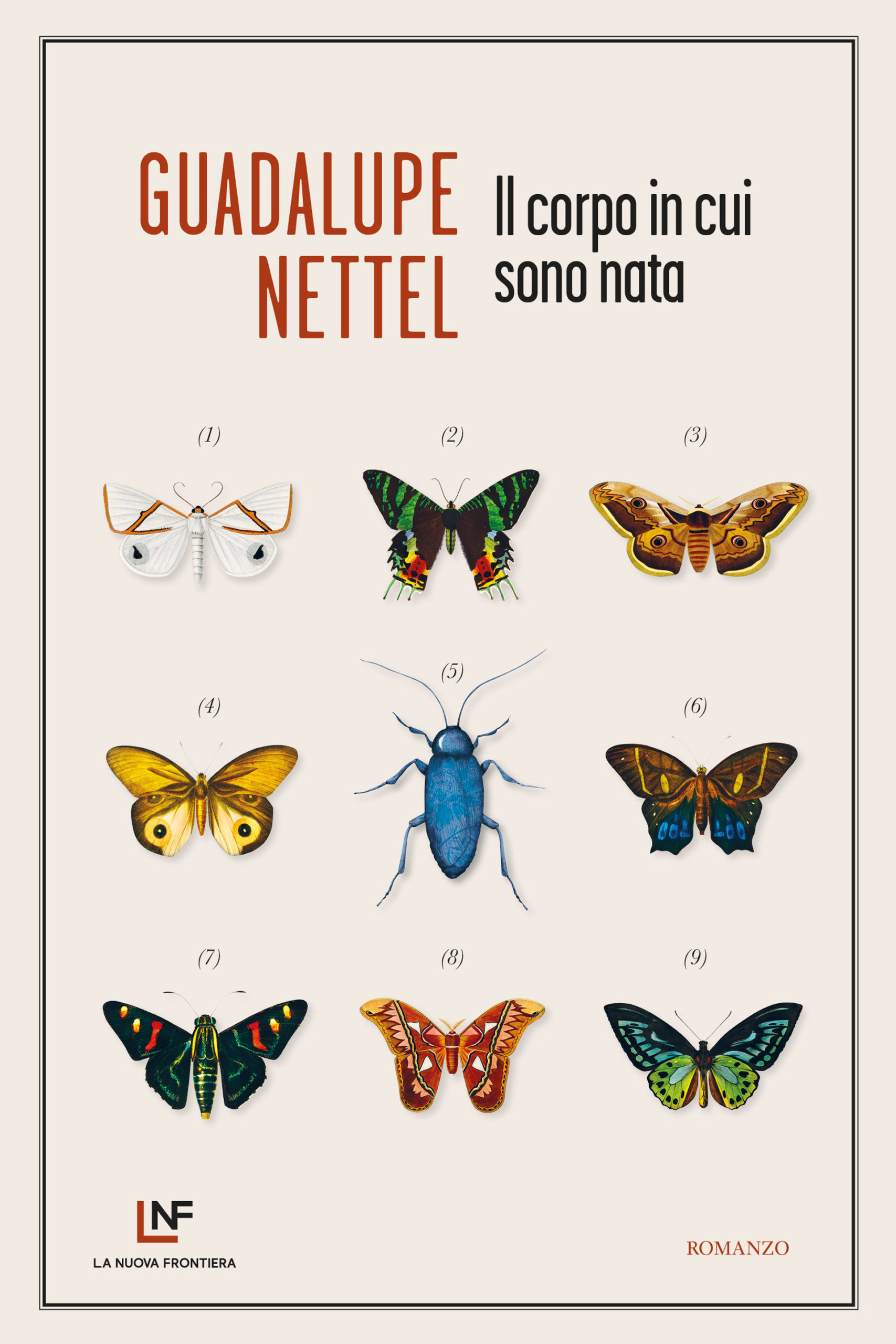
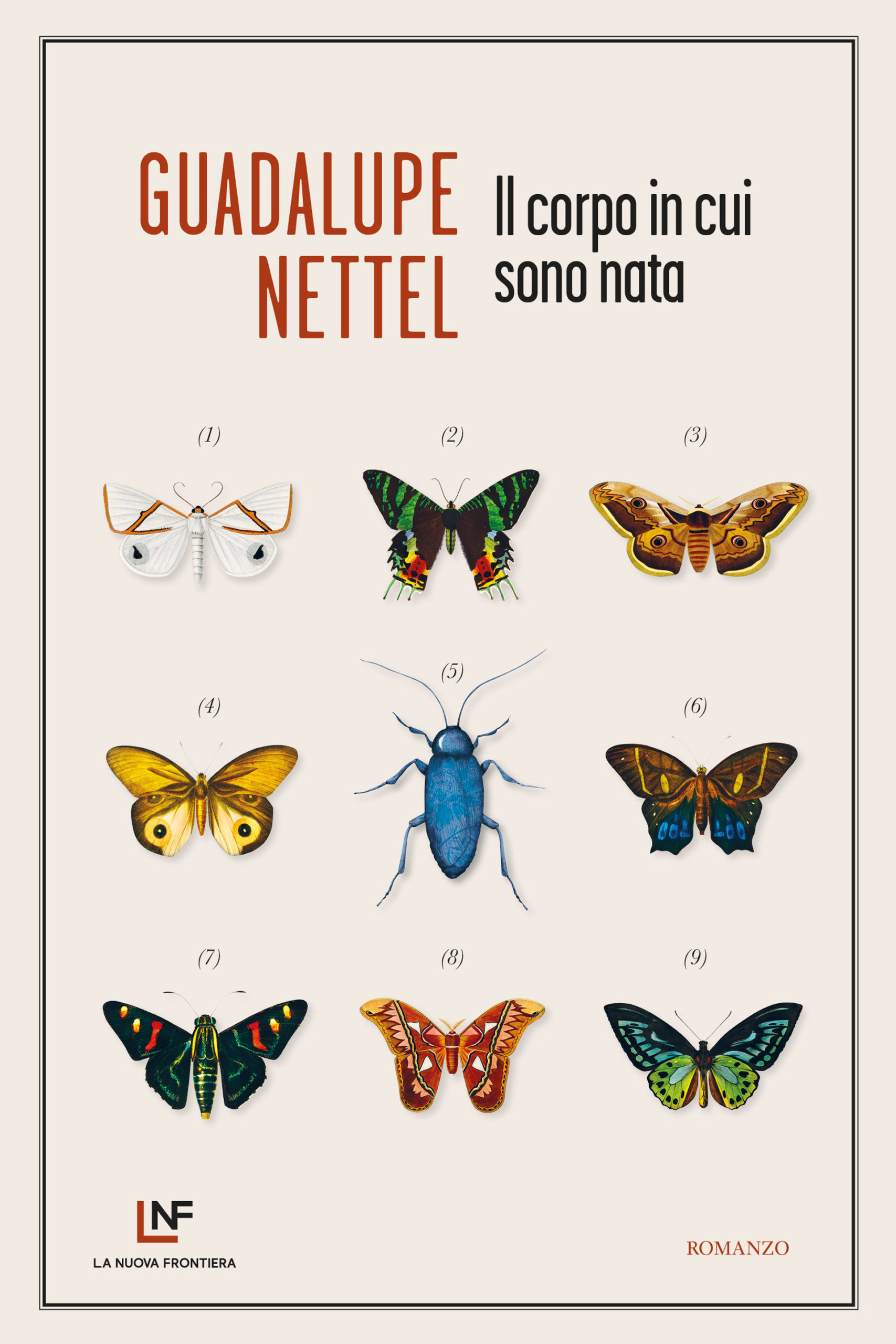
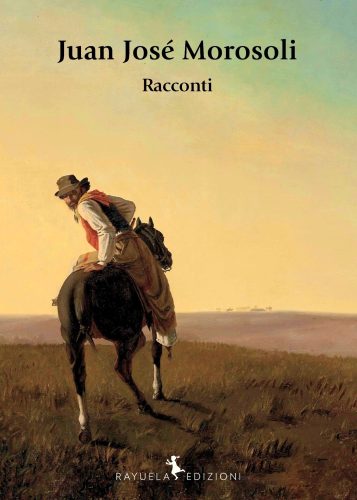
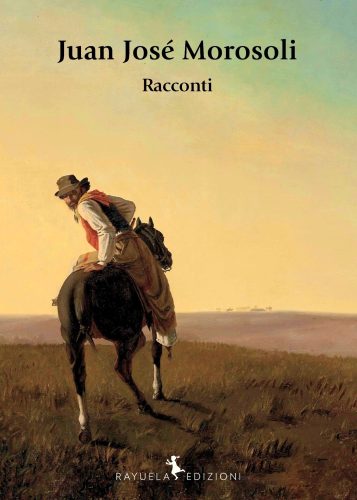
Andrada non ha bisogno di nient’altro che un amico, e ce l’ha: è il bosco, dove, come una pianta qualsiasi, assimila in silenzio sole e tempo e morte. Un giorno lo tirano su, ormai definitivamente solo. Sul suo sonno erano calati albe e tramonti, dove giaceva il suo corpo l’erba appariva come sbiadita, e nell’ampio pascolo luccicava una farfalla gialla, tatuata nel verde accesso delle gramigne.Questo lasciava Andrada nella vita, andandosene via con la morte. Nient’altro che un’impronta, non più estesa del volo di una farfalla nello spazio infinito…
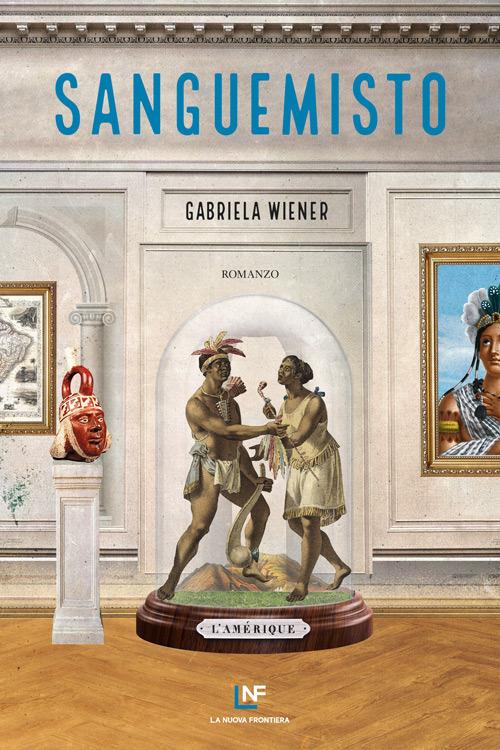
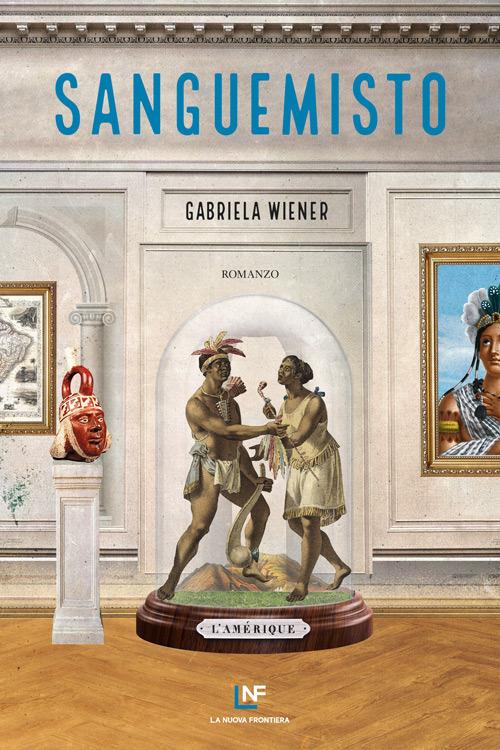
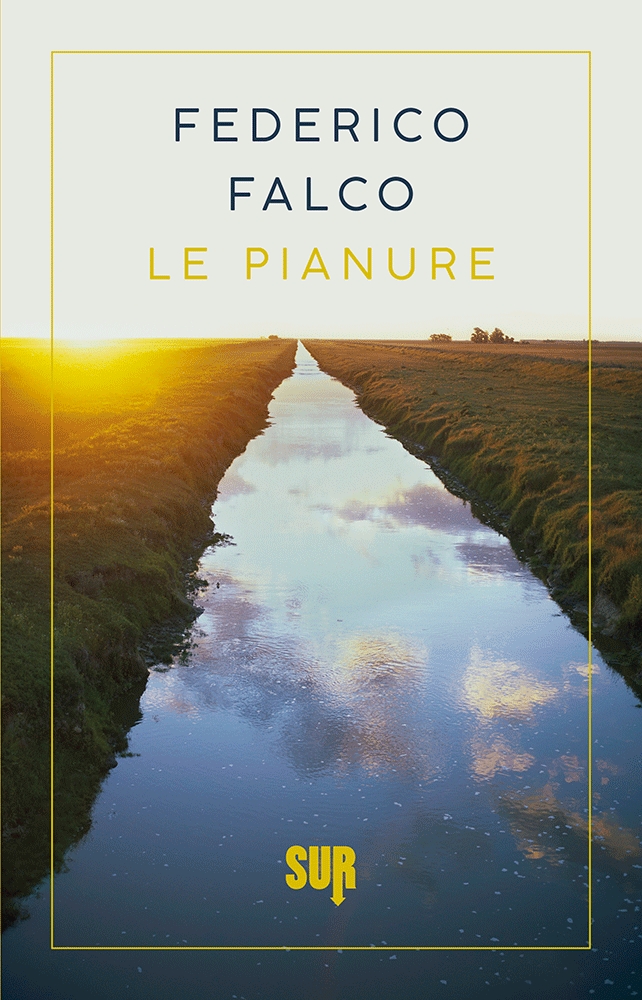
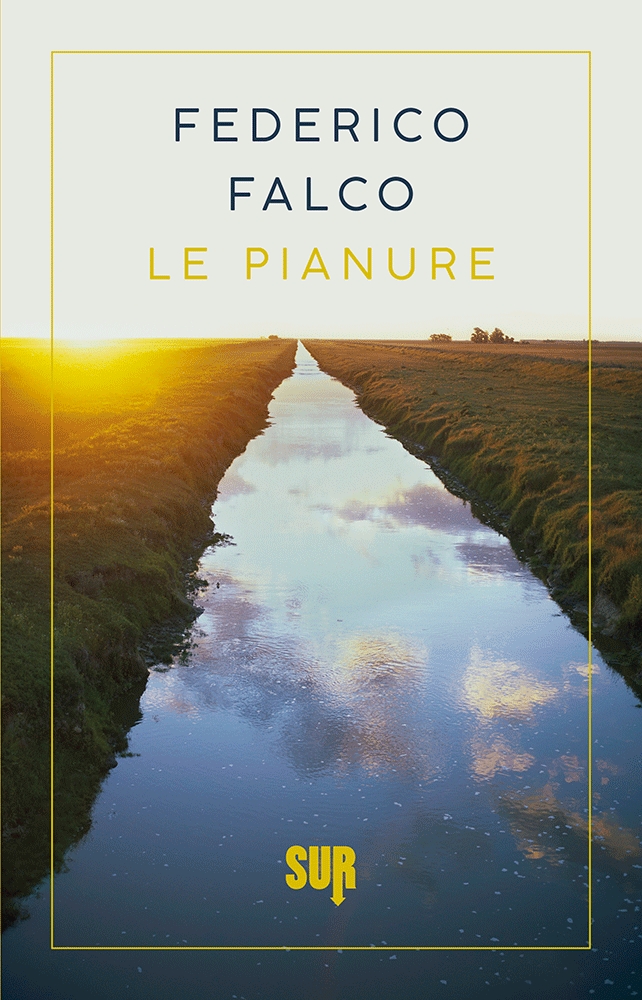
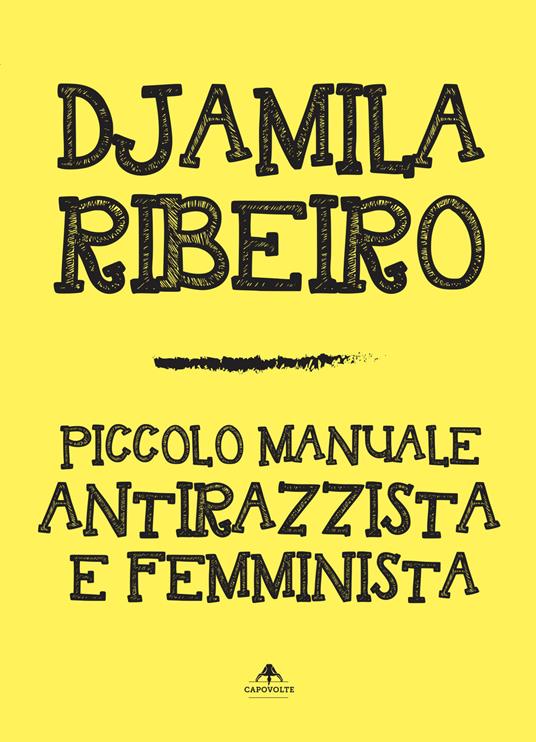
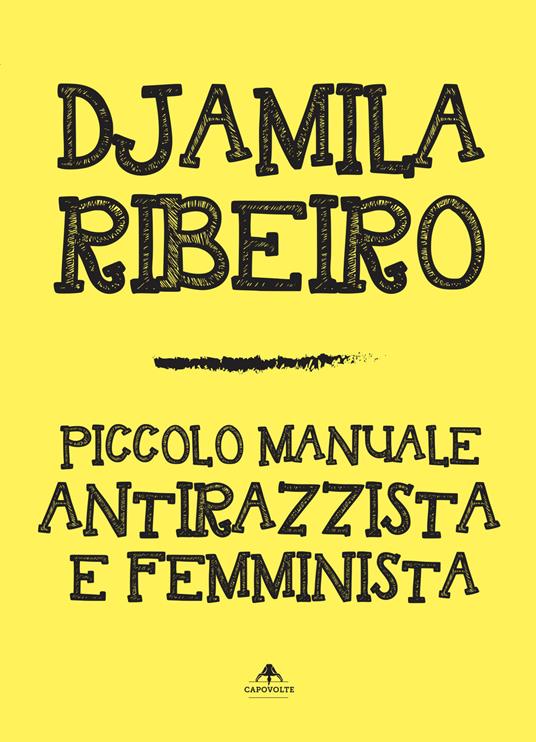
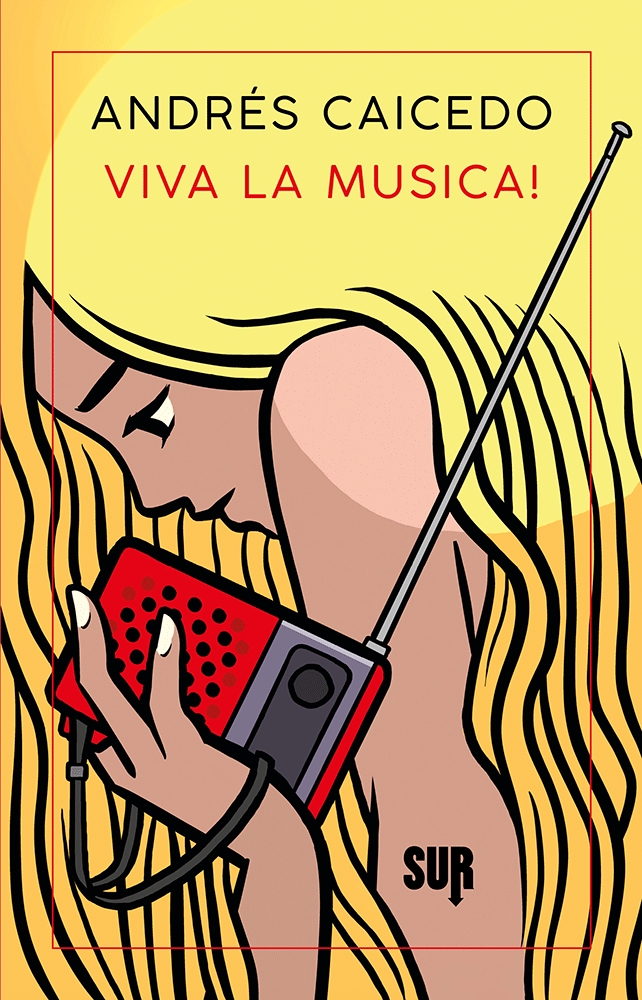
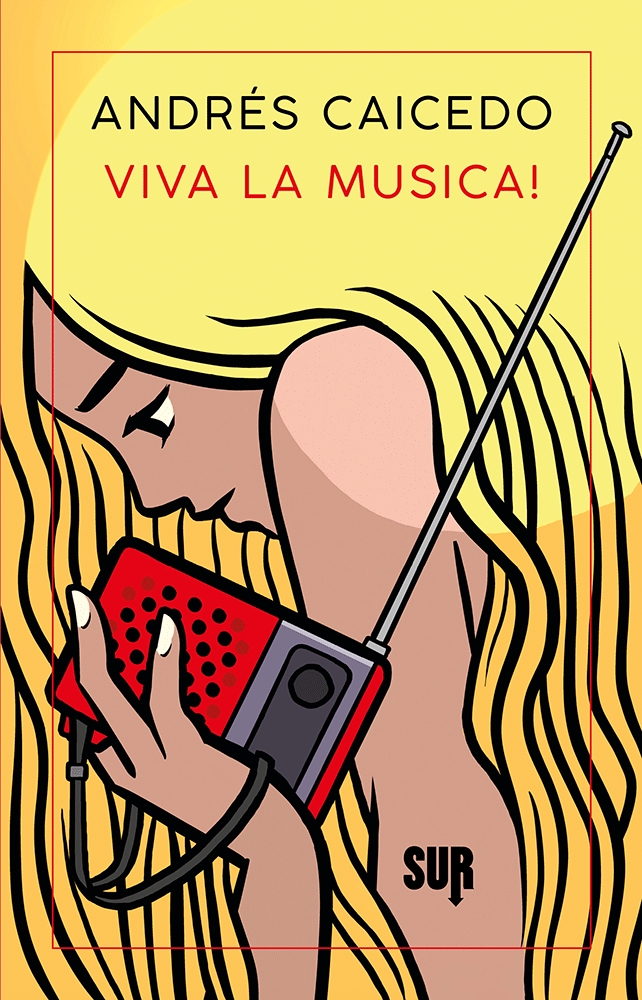
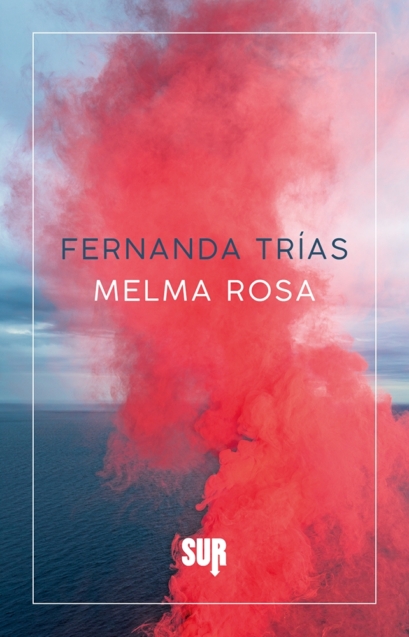
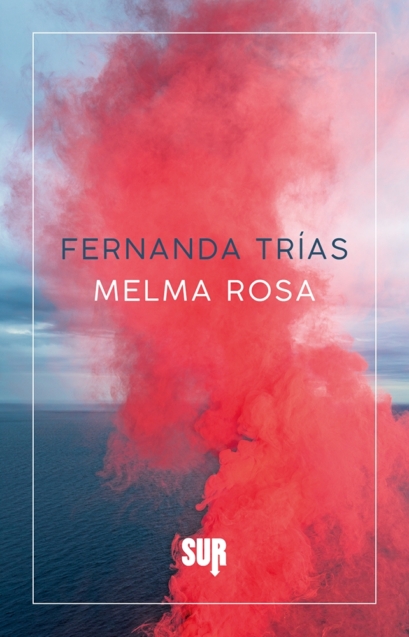
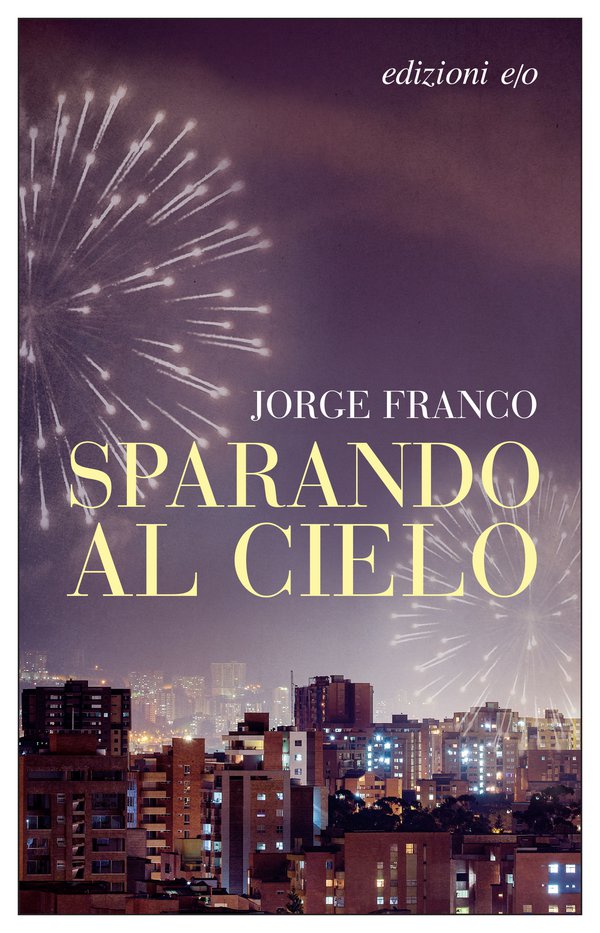
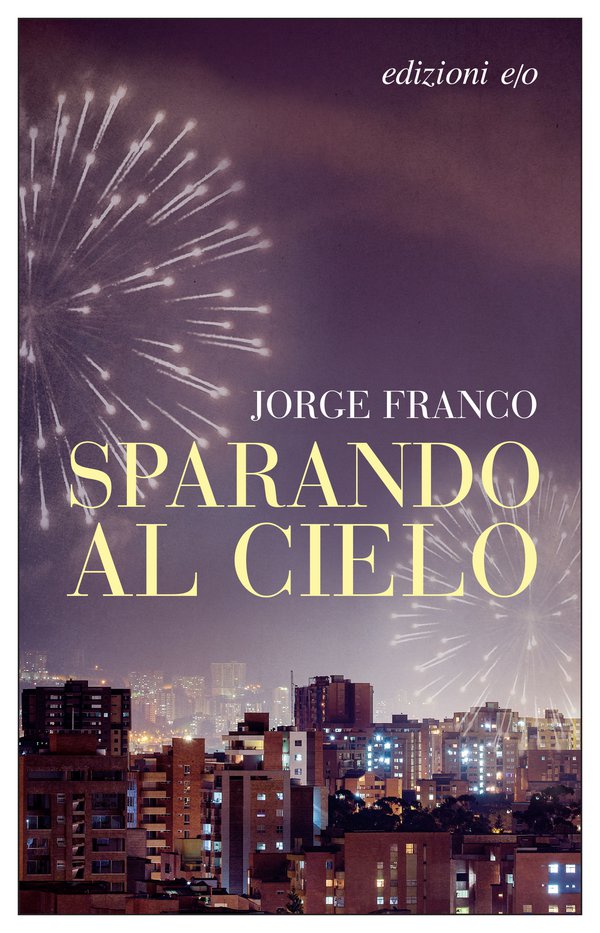
Larry torna a Medellín dodici anni dopo la scomparsa di suo padre, di cui hanno ritrovato i resti in una discarica: ormai vive a Londra, illudendosi di aver chiuso per sempre i legami con un passato doloroso e umiliante, ma seppellire le ossa del padre è un richiamo che lo costringe a tornare e a fare i conti con un passato che non passa... Perché Larry è figlio di un mafioso. Suo padre era non solo in “affari” con Pablo Escobar, ma addirittura amico personale. Larry vorrebbe soltanto rivedere sua madre, ex reginetta di bellezza che fu “la donna del boss”, e che ora vive in squallida solitudine con i rimpianti di un tempo perduto e di fasti effimeri quanto sporchi.
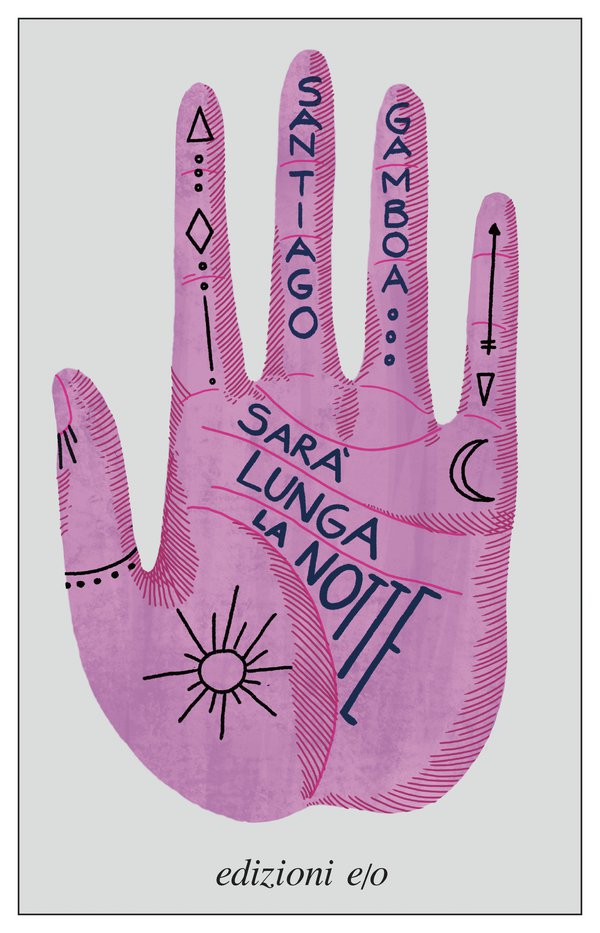
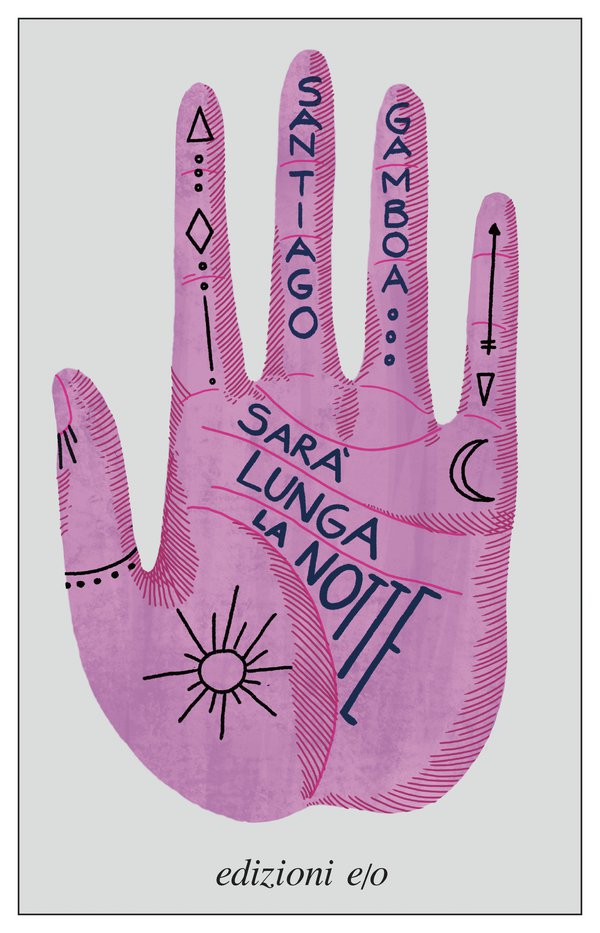
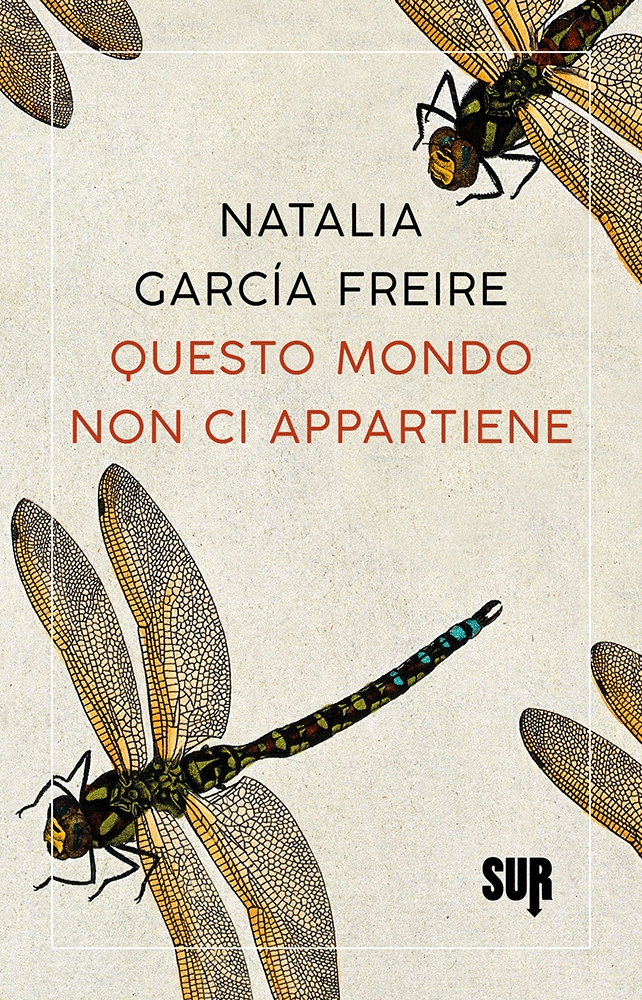
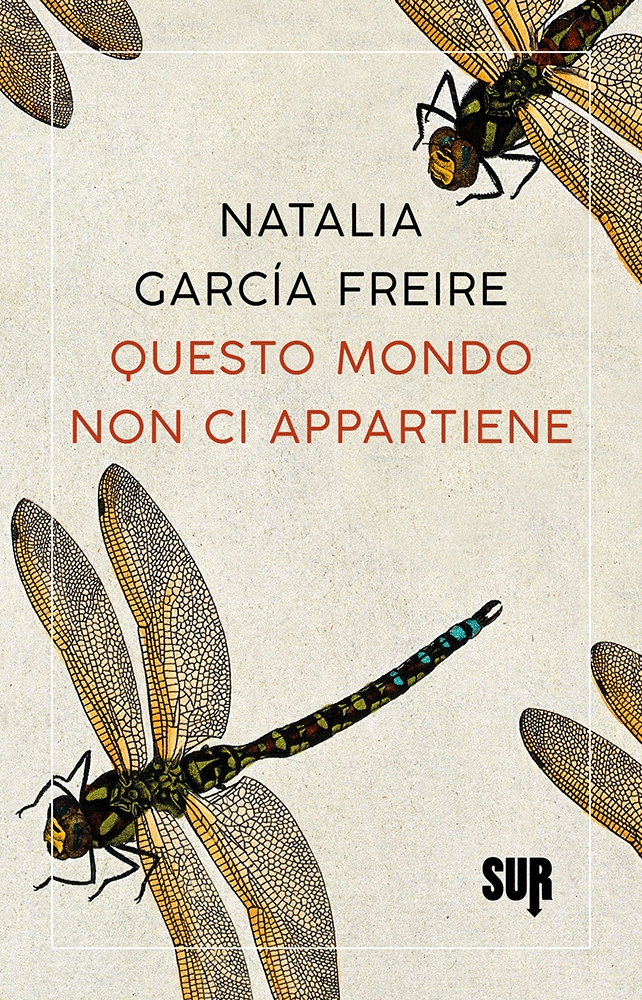
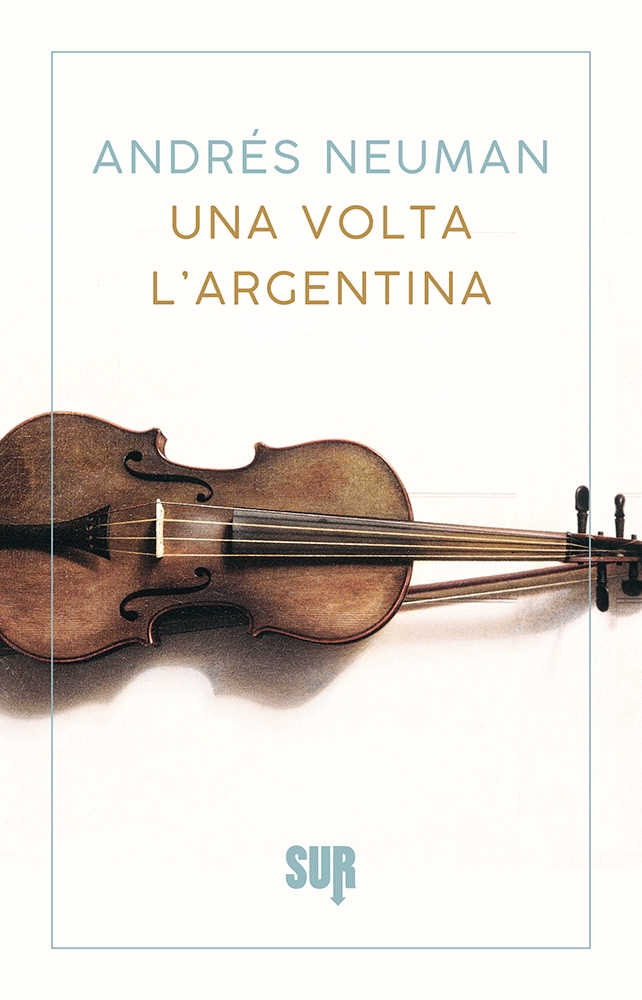
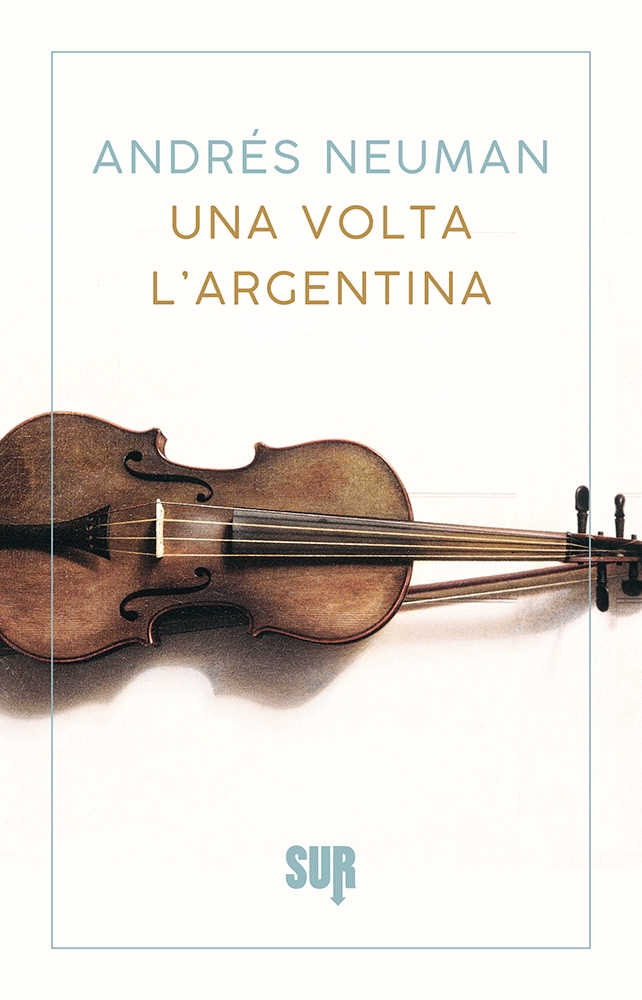
Una volta l’Argentina è il racconto di una famiglia che unisce genti arrivate da ogni angolo del pianeta, e di una terra sconfinata che diventa un paese grande come il mondo. Con una prosa scorrevole e poetica che alterna passato e presente, verità e finzione narrativa, Andrés Neuman ripercorre con humour e tenerezza una genealogia reale e fantastica insieme. Ci sono il bisnonno Jacobo, nato sotto gli zar e scappato dall’Europa in circostanze misteriose; la baba Lidia, lituana dagli occhi color zaffiro; la nonna Blanca, che scriveva lettere e suonava il piano; il prozio Leonardo, dandy del quartiere, e la zia Ponnie, tessitrice di arazzi con la passione per il Brasile: una vivace sinfonia di personaggi indimenticabili, le cui vicende personali fanno da contrappunto alle tragedie e alle rinascite di un intero paese.
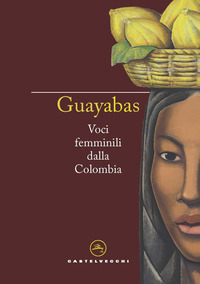
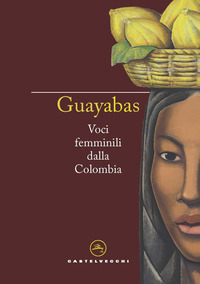
La guayaba, frutto di genere femminile, è il più ricco, nutritivo e profumato del pianeta, e il più rappresentativo degli oltre quattrocento frutti censiti in Colombia: è a queste proprietà che si rifanno i sedici racconti di Guayabas, scritti da sedici scrittrici colombiane e tradotti da sedici traduttrici. Cornice di storie sulla ricerca di sé, sulla maternità, sulla sessualità, tra il realismo e il paradossale, sono le periferie di grandi e convulse aree urbane come i piccoli villaggi rurali in cui il tempo sembra aver perso importanza.
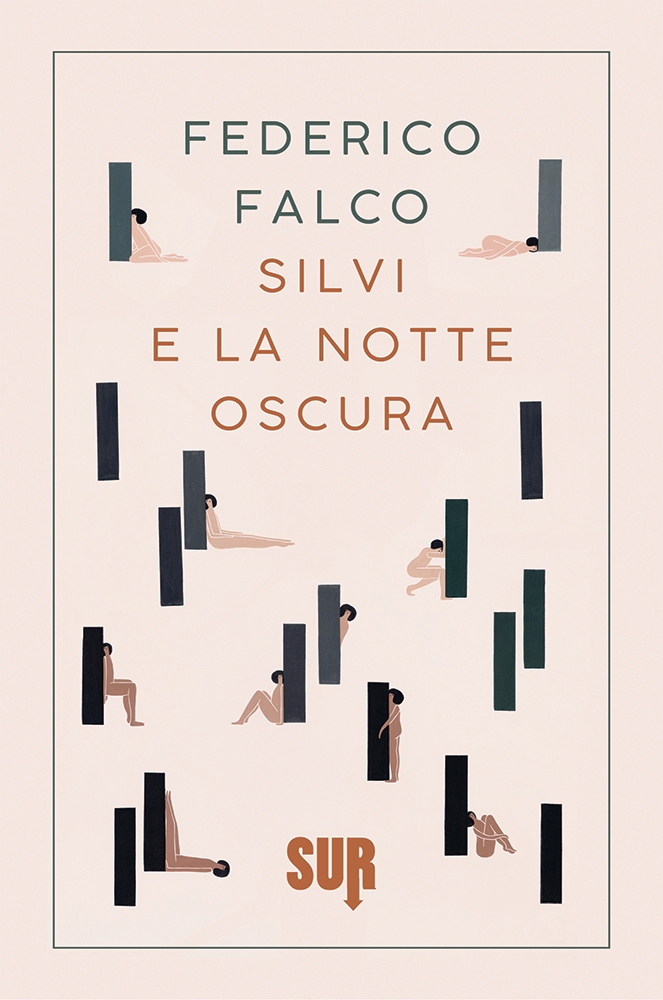
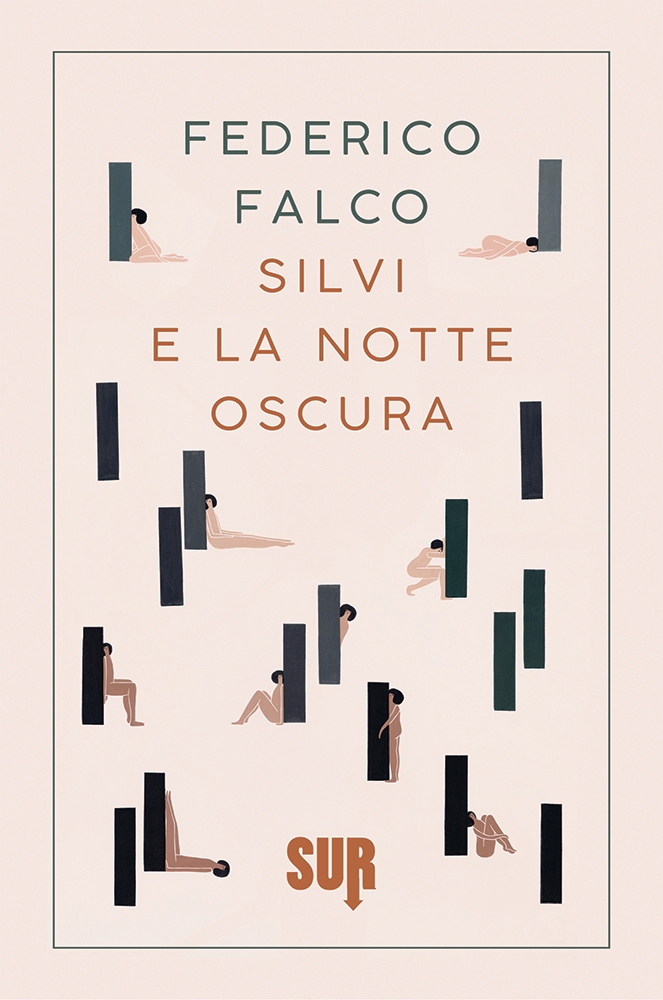
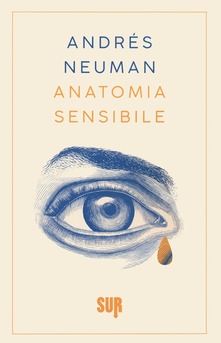
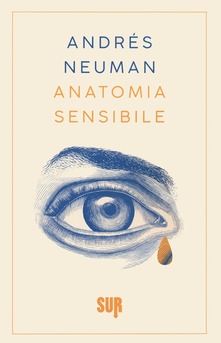
Anatomia sensibile è una mappa letteraria che celebra il corpo in tutte le sue forme e un tributo alla bellezza non convenzionale scritto nella forma di un viaggio poetico, politico ed erotico alla scoperta di ciò che siamo veramente. Un libro che racconta come vediamo noi stessi e come ci guardiamo attraverso gli occhi degli altri, proponendo un ideale estetico dissacrante e inclusivo che mira a scardinare i pregiudizi di genere e sull’apparenza.
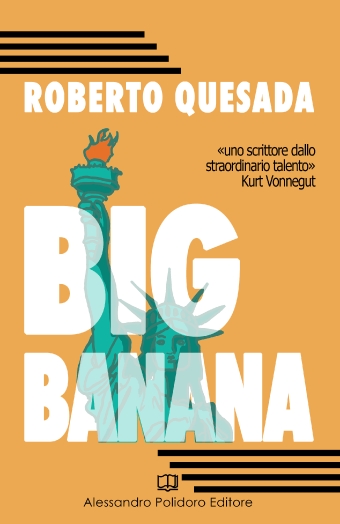
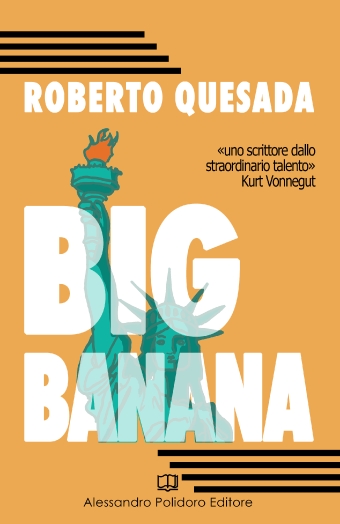
In una New York di fine millennio, su cui incombe la tragedia dell’11 settembre, il giovane protagonista del libro, l’honduregno Eduardo Lin, tenta di affermarsi nel mondo dello spettacolo e intanto sbarca il lunario lavorando come operaio in un’impresa edile. La convivenza con altri latinos della Grande Mela, scandita da feste, droghe e un’assoluta libertà sessuale, delinea un mondo nel quale emergono le luci abbaglianti e i contrasti del sogno migratorio. L’unico filo che ancora lega Eduardo alla terra natale è quello della New York Telephone con cui tiene accesa la passione per la sua Mirian, rimasta in Honduras per costruire un paese migliore anche attraverso il suo attivismo politico.
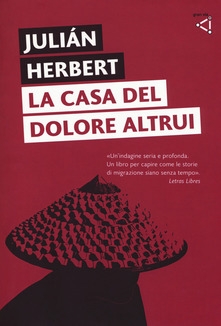
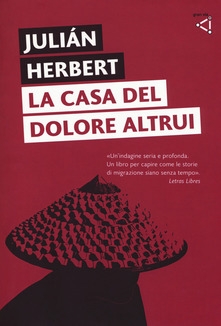
All’inizio del XX secolo, sulla soglia della modernità e del progresso, una vicenda scuote la storia del Messico: tra il 13 e il 15 maggio del 1911, nella convulsa congiuntura che segue lo scoppio della Rivoluzione, parte della comunità cinese di La Laguna viene massacrata, in modo violento e arbitrario, dalle truppe degli insorti e da comuni abitanti della cittadina di Torreón, convertiti in turba incontrollata. Si tratta della più grande strage di orientali nel continente americano, una mattanza seguita prima da negazione e calunnia, e poi da minimizzazione e disprezzo, simboli di una xenofobia dilagante, indifferente alla barbarie.
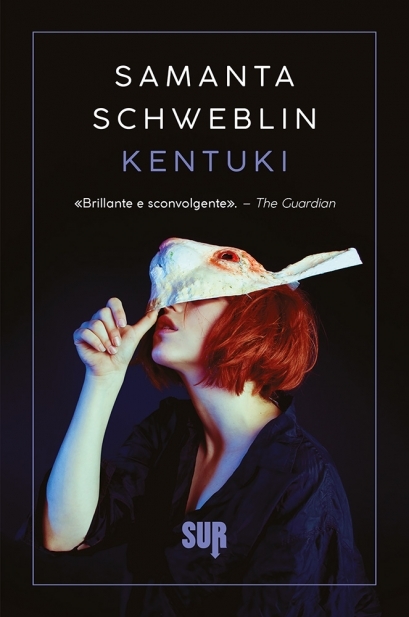
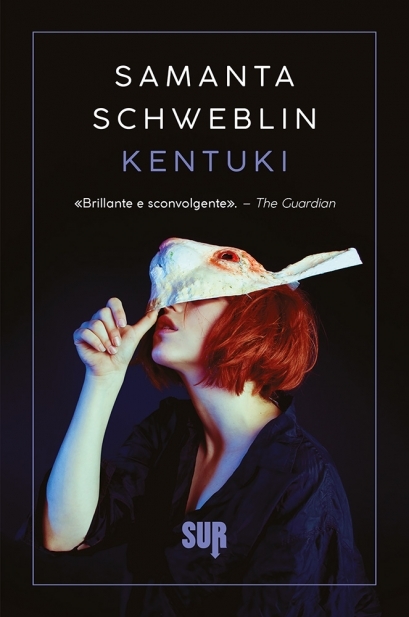
Buenos Aires, interno giorno. Ma anche Zagabria, Pechino, Tel Aviv, Oaxaca: il fenomeno si diffonde in fretta, in ogni angolo del pianeta, giorno e notte. Si chiamano kentuki: tutti ne parlano, tutti desiderano avere o essere un kentuki. Topo, corvo, drago, coniglio: all’apparenza innocui e adorabili peluche che vagano per il salotto di casa, in realtà robottini con telecamere al posto degli occhi e rotelle ai piedi, collegati casualmente a un utente anonimo che potrebbe essere dovunque. Di innocuo, in effetti, hanno ben poco: scrutano, sbirciano, si muovono dentro la vita di un’altra persona.